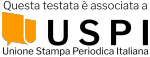Sui cappellani militari si discute da tempo; il fatto che siano inquadrati nell’esercito e stipendiati dal Ministero della Difesa per il loro servizio spirituale, non va giù ai “difensori della laicità dello Stato”. Don Pasquale Moscarelli – incontrato nella base “Millevoi” di Shama, nel sud del Libano, quale “pastore d’anime” dei militari del contingente italiano del Settore Ovest di Unifil, a guida Brigata “Pinerolo” -, è convinto che far parte dell’esercito, anche dal punto di vista formale, agevoli la relazione con i commilitoni. La sua vocazione è nata a dieci anni, ha frequentato il seminario dell’Ordinariato militare di Roma, poi teologia alla Gregoriana; è sacerdote dal 2008 e ha alle spalle missioni in Bosnia e Kosovo. È consapevole che ci sono perplessità – ma anche netta opposizione – rispetto alla figura del sacerdote graduato. Ma don Pasquale è forte della sua esperienza: ha girato l’Italia per celebrare matrimoni di ragazzi conosciuti in missione, per battezzarne i figli, seppellirne i genitori. Amicizie durature, segno che i semi gettati hanno dato frutto.
Don Pasquale, stellette o no per il prete?
«Dire che la cosa mi è indifferente non è corretto, perché le stellette sono funzionali per stare in determinati ambienti; ti contestualizzano, ti inseriscono in un sistema in cui svolgi il tuo servizio come fa ogni specialista dell’esercito, e sei uno di loro. Sono funzionali quindi, non indispensabili. Indossare la divisa favorisce il rapporto con i militari, che ti percepiscono come uno di loro. Mi piace quando vengo chiamato il “nostro don”, dal credente e dal non credente, da colui che rispetta, ma non ha una fede accentuata. Il militare non è costituito per fare la guerra; egli obbedisce alla scelta di tutelare il bene comune, non è il guerrafondaio di turno. Si pone molti più problemi di coscienza il militare, che non un civile nel pronunciarsi con giudizi severi sull’altro. Dover provvedere a volte con la forza non è frutto di una scelta personale, bensì di una contingenza, o comunque di un’obbedienza».
Che cosa fa il cappellano militare?
«Il cappellano militare, al di là del suo aspetto religioso, va considerato un grande mediatore, un filtro, non parlerà di Dio se uno non glielo chiede. Chi viene in chiesa da me, sentirà parlare di Dio, ma non ci si aspetti che io faccia proselitismo. Dio è così delicato, così intimo, che non posso essere io ad imporlo. Con il mio stile di vita, posso aiutare a riflettere, a porsi delle domande, perché non ci può essere fede senza domande. Ma nel momento in cui uno mi chiede di Dio, si mette in ascolto e si lascia parlare, lì sono intransigente, perché le vie del Padre sono intransigenti. Il percorso richiede di smussare gli angoli che possono contrastare con la vita di fede».
Che cosa le raccontano i soldati?
«Sentono di poter parlare della loro anima senza condizionamento, perché sanno che da parte mia ci sarà ascolto, non giudizio. Mi raccontano tutto: dalle cose più belle, dove si sorride, alle cose dove bisogna piangere insieme. In mezzo c’è la quotidianità di ognuno. La missione per molti militari è un canale favorevole per riscoprire la fede; tanti si accostano al sacramento della penitenza dopo decenni. La missione porta la persona all’essenziale, perciò dico ai ragazzi di considerarla un momento di crescita personale. Nel mondo militare non c’è una comunità codificata come la parrocchia, perciò tocca a me prete sapermi guadagnare giorno per giorno la fiducia delle persone. Solo se riesci a conquistarti la fiducia, hai lo spazio per poter esercitare il tuo ministero. Accade che, quando i “miei ragazzi” – li chiamo così dal generale all’ultimo commilitone – si mettono a nudo, parlano senza riserve, senza inibizioni, del loro cuore, della loro coscienza, della loro vita. Nello scoprire tanta umanità, divento più uomo anch’io».
Che cosa pensa del gran numero di ragazzi che parte dall’Europa per combattere in Siria o affiliarsi all’Isis?
«È evidente che la causa è la perdita di valori, di identità, di senso di appartenenza, che connota la nostra società contemporanea. Il ragazzo di oggi, come penso il ragazzo di sempre, ha bisogno di punti fermi, capisaldi indiscutibili. E l’adesione a Isis è vista come un entrare a far parte di qualcosa di serio, di forte, che dà magari un senso di sicurezza, un po’ come erano le ideologie».
Che cosa si può fare per arginare il fenomeno?
«Le istituzioni devono smettere di parlare, devono cominciare a fare. La politica rimarrà un fallimento fino a quando non si metterà davvero a lavorare per il bene. Perché la Chiesa sta vivendo questa freschezza? Perché questo Pontefice alle parole fa seguire i fatti. Basta con le chiacchiere, i ragazzi hanno bisogno di autenticità, testimonianza, concretezza. Alcuni genitori crescono i figli nell’idea che “non voglio che tu patisca quello che ho patito io”; così facendo, li rendono incapaci di sacrificio. Ma se io ho tutto, sono sempre insoddisfatto. I militari sono i prototipi ottimi di cristiani, perché sono abituati al sacrificio, all’obbedienza. Non si tratta di una disciplina formale, ma di uno stile di vita che ritengo valido per me».