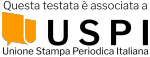Un evento che potremmo quasi definire di “trumpiana” memoria quello che è avvenuto durante la scorsa settimana in Myanmar. Infatti, con le elezioni svoltesi quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, anche nel Myanmar è stato eletto un Governo democratico, a conferma di quanto gli elettori avevano già deciso nel 2015, con l’ingresso della National League for Democracy (NLD) in Parlamento. Infatti, il partito guidato dalla Nobel per la pace Aung San Suu Kyi aveva nuovamente surclassato la giunta militare, storicamente al governo del Paese dagli anni 60, e la sua posizione sembrava sempre più consolidata, sebbene molto criticata per alcune scelte discutibili sul fronte delle libertà e dei diritti umani.
Tuttavia, a differenza di quanto avvenuto negli US, in Myanmar esiste una vera forza politica militare che si è opposta alle elezioni ritenendole fraudolente, ed ha potuto con estrema facilità riprendersi il potere con la forza. Dunque, Aung San Suu Kyi e i leader del partito (si rammenta che Aung San non poteva essere leader del partito per via di una legge promulgata proprio dalla giunta militare nei suoi confronti) sono stati arrestati, i simboli del NLD sono stati rimossi da tutta la città, nella quale hanno iniziato a echeggiare felici caroselli e motivetti pro giunta miliare. Il Myanmar si è ritrovato chiuso a ogni forma di comunicazione dalla domenica al lunedì, con il blocco dei voli nazionali, la chiusura dell’aeroporto internazionale di Yangoon (la capitale) e l’intermittenza dei mezzi di comunicazione, a cui è seguita l’autocensura da parte dei principali reporter, per timore di essere arrestati per le loro idee. Il tutto coronato dalla dichiarazione, resa in diretta tv dal nuovo leader Generale Min Aung Hlaing, dello stato di emergenza per un anno.
Il Myanmar ha dunque ottenuto questo nuovo e increscioso record di un ritorno coatto al regime militare, in continuità con la sua storia moderna, contrassegnata da due brevi parentesi di democrazia, quella dei primi anni dell’indipendenza e la più recente terminata questa settimana.
Eppure a conti fatti tra le due esperienze democratiche quella più importante e degna di portare con sé questa nomea è probabilmente soltanto la prima e più antica democrazia di fine anni 50. Infatti in quell’occasione il governo democratico aveva gettato le basi per la tutela delle minoranze, promulgando una legge sulla cittadinanza che riconosceva a tutte le popolazioni del Myanmar il diritto di essere cittadini. Un diritto che si potrebbe sottovalutare, ma che rivesta un’importanza incredibile soprattutto in un Paese come il Myanmar, al secolo conosciuta come Birmania, dove non si è esitato a rendere apolidi (senza cittadinanza) centinaia di migliaia di abitanti delle regioni occidentali. Ovviamente con il colpo di stato degli anni 60 questa legge è stata ripresa e modificata, arrivando fino ad oggi in tutta la sua essenza e condita da diverse leggi draconiane che si sono accanite contro coloro i quali sono stati ritenuti il capro espiatorio di ogni problematica interna. Questa è la storia dei Rohingya.
In che modo si sono brevemente intersecate le storie dei Rohingya con quella di Aung San Suu Kyi, è una storia interessante che purtroppo richiama alla memoria il gioco delle promesse politiche non mantenute.
La parabola dei Rohingya è di facile e crudele comprensione: un popolo musulmano estremamente povero che vive nello Stato del Rakhine (a sud-ovest del Myanmar, al confine con il Bangladesh), ritenuto di etnia bengalese e mai riconosciuto come degno di avere la cittadinanza birmana. Per tale motivo sono stati costretti negli anni, con villaggi bruciati, indicibili violenze e fosse comuni, a emigrare forzatamente verso il Bangladesh o la lontana Malesia. Centinaia di migliaia di persone costrette ad attraversare un confine e rimandate indietro puntualmente dopo diversi anni, senza aver acquisito nulla ed esposti alle violenze più atroci dell’uno e dell’altro Paese, in condizioni di vita estreme. In poche parole, è stato un genocidio a lungo termine, probabilmente tra i genocidi meno discussi e noti a livello internazionale. Questo è ovviamente reso in maniera molto semplicistica.
A ciò si accompagna parallelamente la storia di Aung San Suu Kyi, figura sotto alcuni versi simile a quella del primo Gandhi, votata alla non violenza, caratterizzata dai fiori nei capelli, da un linguaggio pacato e dedicato alla tutela dei più deboli, dei prigionieri politici e delle minoranze vessate. Aung San è stata per lungo tempo la spina nel fianco della giunta militare in Myanmar. A riprova di ciò, le numerose leggi emanate dalla giunta per minarne la carriera politica e sociale. Seguendo le orme del padre, anch’esso oppositore politico, Aung San ha vissuto 15 anni di arresti domiciliari, è stata costretta ad espatriare nel Regno Unito diverse volte per salvarsi la vita, e per il suo atteggiamento fermo e di non violenza verso i miliari le è stato riconosciuto il premio Nobel nel 1991, ma anche riconoscimenti e premi da parte di tutte le organizzazioni internazionali e di una cittadinanza onoraria. Il culmine della fama di questo personaggio politico è stata raggiunta nel novembre 2015, quando il suo partito NDL, come detto non guidato personalmente da lei, ha vinto le prime nuove elezioni democratiche del Paese con molte promesse di rinnovamento e di inclusione. È bene considerare che la legge adottata dalla giunta militare che ha indetto queste elezioni, ha previsto una quota (pari al 25%) dei seggi riservati alla giunta stessa, mantenendo dunque una parte di potere. Ciononostante Aung San ha vinto le elezioni e ha iniziato a governare il Paese, con due capisaldi: liberare i prigionieri politici e difendere le minoranze vessate dal vecchio regime, condannando gli artefici del male.
In cinque anni di governo, la leader democratica non ha mantenuto alcuna delle promesse fatte, dimostrandosi a tutti gli effetti una politica e non un difensore dei diritti umani come si era descritta. Da qui la decisione delle organizzazioni internazionali, tra cui Amnesty, di revocare seduta stante tutti i riconoscimenti assegnati a colei che appariva come la paladina dei diritti umani (non è stato possibile revocarle il Nobel invece perché non è possibile secondo lo Statuto). Infatti la Aung San, oltre a non aver provveduto a liberare gli oppositori politici (tra cui i giornalisti di Reuters che denunciarono le violenze verso i Rohingya) e a non aver tutelato la minoranza Rohingya (addirittura neanche definita come tale, ma solamente in maniera spersonalizzata “un’etnia musulmana”), ha addirittura scusato e giustificato le azioni della giunta militare nei confronti dei Rohingya. Si è potuto assistere all’apice di tali atteggiamenti nell’agosto del 2017, quando l’esercito ha intensificato la sua brutale campagna contro i Rohingya, costringendo 750.000 membri della minoranza etnica musulmana a fuggire nel vicino Bangladesh in una delle più grandi ondate globali di rifugiati in una generazione. I funzionari delle Nazioni Unite hanno detto che i roghi di massa dei villaggi Rohingya, completi di esecuzioni sistematiche e stupri, sono stati eseguiti con intento genocida. Nonostante ciò, la leader non ha fatto nulla, anzi è stata complice nel non aver quantomeno condannato questi atti.
L’atteggiamento di Aung San è stato da molti giustificato come un modo per contemperare il potere militare e mantenere una seppur vaga e solo formale parvenza di democrazia. Per altri ella sarebbe stata mossa anche dal fatto che appartenendo alla maggioranza etnica del Paese, non ha mai sentito veramente sua la causa dei Rohingya. Il conto è stato purtroppo presentato dalla storia ed è molto salato. Aung San e con lei tutto il Myanmar democratico hanno perso l’occasione di tutelare i più deboli del loro Paese, la possibilità di denunciare apertamente e dall’interno i crimini commessi dalla giunta militare e di permettere ad attori internazionali (dalle Nazioni Unite alle organizzazioni umanitarie) di fare ingresso nel Paese per documentare quanto ivi succede e per supportare la popolazione locale. Tutto questo perché, è utile sottolinearlo, le Nazioni Unite non hanno la possibilità di intervenire a causa del veto imposto dalla Cina sulla situazione in Myanmar e quindi impasse sbloccabile solo dall’interno, da un governo democratico coraggioso. Quello che purtroppo non è avvenuto, e ci si rammarica per una grandissima occasione persa per tutelare una delle popolazioni più discriminate e vessate al mondo come i Rohingya e in generale tutti i birmani.
E mentre i governi occidentali, con le mani legate a livello operativo, non possono far altro che dispiacersi per la situazione del Myanmar e condannare apertamente il colpo di Stato, risuonano lapidarie le parole di Thant Myint-U, uno storico del Myanmar: “Il Myanmar è un paese già in guerra con sé stesso, inondato di armi, con milioni di persone che riescono a malapena a sfamarsi, profondamente diviso lungo linee religiose ed etniche. Le porte si sono appena aperte su un futuro diverso, quasi certamente più oscuro.”