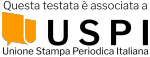La giustificazione di ogni dittatura dall’alba dei tempi e di ogni governo autocratico si fonda sul, ritenuto, consenso del popolo, o meglio della richiesta spasmodica di aiuto da parte della popolazione. Non fa eccezione la storia del colpo di stato in Myanmar. Infatti, la giunta militare quando ha preso il potere a inizio febbraio, spodestando la leader Aung San Suu Kyi e i membri del suo partito, ha annunciato di essere stata costretta ad agire a causa di massicci brogli elettorali nelle elezioni dello scorso novembre, che sono state clamorosamente vinte dalla Lega Nazionale per la Democrazia. I generali hanno detto che avrebbero tenuto le elezioni entro un anno. Ma il calendario delle future elezioni è già stato spostato a uno o due anni, secondo le dichiarazioni dei media statali. Si consideri che l’ultima volta che i militari hanno annullato i risultati di un’elezione, nel 1990, c’è voluto un quarto di secolo perché si tenessero di nuovo elezioni generali complete ed eque. La storia potrebbe ripetersi nuovamente.
Dunque il golpe è stato giustificato dalla tutela degli interessi del popolo birmano. Quello stesso popolo che tuttavia ha iniziato a ribellarsi energicamente all’ennesima occupazione territoriale e mediatica dei militari, ricevendo un trattamento non del tutto tutelante.
Infatti, si sono susseguiti nel corso dell’ultimo mese numerosi scioperi e proteste, repressi puntualmente nel sangue dalla violenza dei militari guidati dalla giunta. L’ultimo in ordine cronologico è stato lo sciopero generale indetto lunedì scorso che ha bloccato la produzione e il commercio su tutto il territorio birmano.
Tra i manifestanti, almeno due sono stati uccisi lunedì a Myitkyina, una città nel nord del Myanmar, dove le suore cattoliche romane si sono inginocchiate per supplicare i soldati di fermare le uccisioni. Un altro manifestante è stato colpito mortalmente all’addome a Pyapon, una città non lontana da Yangon, la capitale commerciale del Myanmar. E nella stessa Yangon, centinaia di persone sono rimaste intrappolate in un cordone delle forze di sicurezza lunedì sera, temendo un arresto o peggio. Finora più di 60 persone sono state uccise e circa 1.800 persone sono state arrestate dall’inizio del golpe.
A livello di repressione mediatica e sociale, il cosiddetto blackout informativo, si aggiunga che lunedì sera, le restrizioni sono diventate ancora più severe quando la televisione di stato, che ora è controllata dai militari, ha annunciato che le licenze sono state revocate a cinque organizzazioni di media indipendenti, un duro colpo a quella che era stata la vibrante stampa libera della nazione. Decine di giornalisti sono stati arrestati e la revoca delle licenze dei media potrebbe ora rendere illegale il loro stesso atto di riferire.
Inoltre, da domenica 7 marzo le forze di sicurezza sono scese nelle università, negli ospedali e nei complessi delle pagode buddiste, dove hanno istituito centri operativi di fortuna. Nella città di Mandalay, nel Myanmar centrale, camion militari hanno preso d’assalto campus universitari, tra cui l’Università Tecnologica di Mandalay, dove un convoglio di quattro veicoli è arrivato tra gas lacrimogeni e proiettili di gomma, secondo i testimoni. “Penso che stiano cercando di preparare una guerra brutale contro il popolo”, ha detto una guardia di sicurezza dell’Università Tecnologica di Mandalay. L’abate del Tempio di Buddha Mahamuni a Mandalay ha detto che i soldati hanno occupato il terreno della pagoda per un mese. “Nessuno viene più ad adorare qui perché la gente ha paura di loro”, ha detto.
In un articolo di lunedì 8 marzo del Global New Light of Myanmar, giornale sotto il controllo della giunta militare, è stato “chiarito” che tali spazi sono stati occupati perché i membri del pubblico hanno chiesto che il Tatmadaw, come è conosciuto l’esercito in Myanmar, “controlli le università e gli ospedali pubblici e agisca efficacemente per il bene del popolo”.
Quello stesso popolo che continua a subire trattamenti brutali proprio dal Tatmadaw, reo di avere una lunga sfilza di atrocità sulle sue spalle. Negli ultimi anni infatti, il Tatmadaw ha condotto una guerra serrata contro i gruppi etnici ribelli in tre stati – Rakhine, Shan e Kachin – e ha sfollato 700.000 musulmani Rohingya. Sopravvissuti e testimoni hanno descritto una campagna brutale, tra cui uccisioni, stupri sistematici e abusi. I soldati hanno spesso usato uomini e ragazzi come scudi umani, come raccontato da diversi testimoni. Per esempio, Sayedul Amin, un Rohingya di 28 anni, ha dichiarato che a ottobre 2020 è stato catturato insieme ad altri Rohingya e gli è stato ordinato di camminare di fronte ai soldati, rimanendo colpito da due proiettili.
Ed è ancora lo stesso popolo tutelato, almeno a parole, dalla giunta che da giorni chiede l’intervento delle Nazioni Unite secondo il principio della “responsabilità di proteggere” (“R2P”), che permette l’intervento della comunità internazionale “se i mezzi pacifici sono inadeguati e le autorità nazionali non riescono manifestamente a proteggere le loro popolazioni da genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l’umanità”.
Quello stesso principio nato a metà anni ’90 dopo i falliti tentativi di tutelare le popolazioni civili in Ruanda e nella ex-Jugoslavia e recentemente utilizzato nel 2011 per giustificare l’intervento militare straniero in Libia. Dunque durante le manifestazioni, civili hanno portato cartelli giganti per le strade chiedendo ai militari stranieri di invadere il Paese.
Dal canto suo, la comunità internazionale ha condannato verbalmente la presa di potere del Tatmadaw, con alcuni paesi che hanno inasprito le sanzioni mirate agli ufficiali militari e alle aziende militari. Tuttavia i più importanti investitori stranieri del Myanmar, come Singapore e la Cina, non hanno fatto passi significativi per punire finanziariamente i militari, riducendo significativamente le sanzioni mosse dagli attori internazionali.