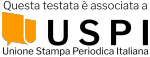Sapevo già del disincantato distacco del Pontefice, maturato nel tempo nei decenni di apostolato tra le bidonvilles di Buenos Aires, nei confronti dei “beni” del cosiddetto patrimonio artistico e culturale plurimillenario dell’umanità.
La dice lunga il fatto che la Cappella Sistina l’abbia vista per la prima volta in vita sua quando partecipò al conclave che elesse Papa Benedetto XVI. I codici miniati e i manoscritti d’epoca lo colpiscono molto relativamente, lui è un uomo pratico e concreto, al quale piace andare al sodo della pratica di vita evangelica, facendo molta attenzione a non perdersi dietro i mille vicoli dello spesso interminabile labirinto delle ricerche e delle avventure intellettuali e culturali.
A Papa Francesco è l’uomo che interessa, a trecentosessantagradi e a tutti i livelli; certamente, uomo che come è ovvio per poterlo conoscere, comprendere e capire in qualche modo e da qualche parte lo devi avere studiato, ma per lui questo è uno studio che non può rimanere confinato per sempre tra le quattro mura di un dicastero vaticano, di un museo o di una biblioteca; è uno studio che a un certo punto deve capire quanto sia essenziale decidere di uscire da se stesso, di lasciarsi la scrivania dietro le spalle e di mettersi in gioco nel rischio sempre implicito per chi sa preferire la presa del largo allo scompartimento stagno di chi rimane ancorato al molo di partenza.
La Chiesa di Francesco non vuole essere una chiesa semplicistica o massimalista, o una Chiesa che separa lo studio e la cultura ignorando la complessità della situazione e della condizione esistenziale dell’uomo postmoderno e contemporaneo.
E’ ben altro che una Chiesa ingenua ed intellettualmente infantile. Non lo era già quella di San Francesco di Assisi, profilo di uomo molto spesso male indovinato e banalizzato, figuriamoci quella del primo Papa gesuita della storia, agli inizi del terzo millennio. Però di sicuro la Chiesa di Papa Francesco vuole diventare una Chiesa sempre meno a forza centripeta e sempre più a forza centrifuga, che non si rinchiude dentro a torri o roccaforti di cultura e di sapere plurisecolari che al posto dell’odore delle pecore al massimo possono vantarsi della magra e di per sé umanamente sterile fragranza delle carte e delle pergamene d’epoca, ma forte del proprio valore, della propria identità, del proprio sapere e del proprio mandato, riesce a capire che tutto il tempo dedicato allo studio delle lingue antiche e dell’esegesi biblica servirebbe a poco se non si trovassero anche spazi e canali aperti perché i concetti e le idee non rimangano astratte ma diventino cibo, perché la parola diventi carne, e la propria vita finalmente prassi evangelica ed esperienza vissuta.
Dovrebbe diventare l’altro da me il vero scopo del mio leggere, del mio cercare, del mio sforzo di accrescere il mio sapere e di migliorarmi come uomo e come credente. È per l’altro che io debbo lavorare, in funzione di lui, in vista di lui.
Non si dovrebbe perdere di vista questa dimensione spirituale comunitaria che innerva e vivifica tutta quanta la nostra sacra scrittura, dall’antico al nuovo testamento. Non basta in quanto tale il pane consacrato sull’altare, non bastano come non sono mai bastate neanche le pur lodevoli ed indispensabili mense Caritas.
Tutto ciò che siamo e che ci rappresenta vitalmente dovrebbe diventare cibo dato in sacrificio per il nostro prossimo e per gli altri. Il nostro tempo, il proprio lavoro trasformato in servizio, il proprio sapere, non tenuto nascosto nei depositi e nei forzieri dei meandri della nostra ricca e meravigliosa psiche umana, ma spezzato e condiviso come pane vitale, come corpo dell’anima. Di tutto questo si sente molto il bisogno e la necessità, ma soprattutto vorrei dire del come, oltre che del cosa. Sarebbe tempo di decentrare le attenzioni e le iper-riflessioni dal vissuto interiore ed emotivo soggettivo, e di focalizzare un nuovo centro per ogni nostro personale sistema solare esistenziale, un centro dove Dio e il prossimo siano in pole position.
Sarebbe tempo di dimenticarmi dei miei mille pensieri, spesso sempre gli stessi, dei miei problemi e delle mie preoccupazioni, e pensare e preoccuparmi soprattutto di questo onnipresente compagno di viaggio straniero, di questo costante alter ego di Cristo al fianco, di questo “altro da me” con tutti i suoi limiti e i suoi punti di forza, i suoi difetti e i suoi valori, i suoi problemi e i suoi cavalli di battaglia, riconoscendo una imprescindibile reciprocità perché ciascuno possa inseguire, perseguire e trovare, in un continuo esodo dal proprio faraonico ego verso la terra promessa della vita e della libertà, la pienezza della propria maturità come uomo e della propria felicità.
Bisognerebbe davvero cominciare a fare questo che Papa Francesco ci chiede di fare, gettandosi dietro le spalle il proprio esasperante ed incarcerante egocentrismo, e cominciando gradualmente, progressivamente a pensare più agli altri che non a se stessi, a vivere più per gli altri che non per se stessi, a prendere il largo nel grande mare magnum della vita e dell’esistenza umana.
Tutti siamo già, anche se molte volte ancora non lo sappiamo, figli dello stesso Padre Celeste, Creatore del cielo e della terra. Siamo tutti spiritualmente vincolati ed interdipendenti in funzione di questa stessa figliolanza, di questo minimo comune denominatore spirituale fra tutti, una unica fonte creatrice che si rifrange, attraverso il prisma del perenne e molteplice atto creativo, nei numerosi e di fatto infiniti aspetti e frammenti che contribuiscono a comporre la visione della vita nell’universo. Urge un risveglio di questa coscienza ecclesiale universale, di questo senso di “appartenenza” ad un corpo vivente allo stesso tempo personale ed infinito, invisibile ma reale, che mi trascende per qualità e dimensioni e pur tuttavia del quale anche io, come tutti, anche quando non lo so, anche quando me ne dimentico, ne rappresento una importante e fondamentale cellula vivente, senza la quale questo stesso immenso corpo non potrebbe fare a meno, senza la quale lui stesso e noi con lui non potremmo né esistere, né vivere, né sopravvivere.
Quanto è importante questo “pensiero secondo”, come lo chiamava la grande filosofa ebrea tedesca Hannah Arendt, che prende in considerazione le cose al variare delle situazioni, che non rimane astratto ma che sa prendere forma e vita nel relazionarsi in via secondaria ai dati offertici dall’ambiente e dagli oggetti esterni, e che ambisce con tutto se stesso a cercare il regno di Dio costantemente rivolto verso le periferie dell’esistenza dove il pensiero tende con sempre maggiore determinazione e anche con una sempre più grande capacità di semplicità, come diceva ancora la Arendt, a rimanere “fedele alla realtà delle cose”… ultima spiaggia dove finalmente si potranno dissolvere le emanazioni residue del nostro unico vero acerrimo nemico che altri non è se non il nostro stesso falso Ego, e prima linea di partenza verso il mare aperto, all-inclusive, al di là del bene e del male, di stati di coscienza superiori, dell’Essere, di Dio.