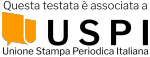Il governo di Benjamin Netanyahu, primo ministro di Israele, ha proposto e iniziato ad attuare un piano di espulsione/rimpatrio volontario di più di 35mila migranti provenienti per la maggior parte da Sudan ed Eritrea. Le persone coinvolte sono arrivate sul territorio israeliano tra il 2006 e il 2012. Questo perché dal 2013 il primo ministro aveva eretto una barriera di confine per bloccare i flussi di africani provenienti dall’Africa. Già nel 2014 si era parlato di un programma di “rimpatrio volontario” per richiedenti asilo sulla base di pressioni e incentivi economici governativi.
Oggi questo piano sembra essere divenuto realtà. In concreto, da quanto è trapelato da fonti governative, gli avvisi di espulsione prevedono il rimpatrio in un paese africano sicuro, non meglio specificato. Sicuramente non saranno Sudan né Eritrea, paesi martoriati da guerre e carestia. Si suppone possano essere Uganda o Rwanda, nonostante i referenti governativi dei paesi abbiano negato qualunque tipo di accordo e relazione diplomatica su questo fronte (il Rwanda ha preso posizione contro tale programma, precisando che non accetterà alcun tipo di rimpatrio). Ad ogni modo, ad oggi sono stati consegnati circa 20mila avvisi di espulsione con la previsione di due differenti opzioni: il rimpatrio volontario in cambio di 3.500 dollari oppure la reclusione in un centro di detenzione per un termine non meglio specificato.
Non sono mancate critiche e risposte dure da parte del mondo degli attivisti e religiosi ebraici. Infatti, sulla scorta della storia di Israele e delle ragioni per le quali il paese è stato creato, è stato istituito un movimento ispirato ad Anna Frank, secondo il quale se il governo seguiterà nell’attuazione del programma, la popolazione nasconderà i migranti nelle proprie abitazioni (proprio come successe per gli ebrei perseguitati durante la seconda guerra mondiale). Alcuni accademici si sono rivolti con una lettera al premier israeliano denunciando con pacatezza questa decisione, ritenuta paradossale per un paese composto da persone che hanno vissuto come rifugiati e sanno cosa significhi non avere un paese che può proteggerti e tutelarti. A livello morale fa effetto sentire che un governo ebraico espella persone verso persecuzioni e violenze.
Mentre si tenta di firmare appelli per fermare questo piano, Netanyahu ha precisato che la sua presa di posizione non viola alcuna disposizione del diritto internazionale, poiché i rimpatri non avverranno in territori dilaniati dalla guerra e coloro che subiranno questi provvedimenti di espulsione sono persone senza un regolare permesso di soggiorno. Le agenzie per i diritti umani, tuttavia, ritengono vi sia più di un presupposto per dubitare della buona fede di Netanyahu. Sembra infatti che il governo abbia attuato negli ultimi anni una politica per ostacolare il riconoscimento della protezione a chicchessia. Si consideri che sulle 15mila richieste presentate solamente dodici siano state accolte.
Le ragioni sono molteplici. I partiti di estrema destra e nazionalisti sostengono che Israele non possa essere “una agenzia per il collocamento” (come riferito da Ayelet Shaked, ministro della Giustizia e membro del partito Focolare ebraico). Una parte della popolazione ha paura che la criminalità possa aumentare e il paese indebolirsi con la presenza sul territorio di tutti questi migranti. L’Economist ha ribaltato queste considerazioni, sottolineando come il paese sia in forte crescita, con un tasso di disoccupazione basso e bisognoso di manodopera. Inoltre, non si comprende come possano incidere 34mila stranieri su uno stato come Israele che conta 9 milioni di abitanti. Per concludere Israele prevede ancora la “legge del ritorno” (tutti gli ebrei hanno diritto a recarsi nel paese e stabilirvi la propria casa) come unico modo per risiedere per un lungo periodo nel paese, non prevedendo procedure di naturalizzazione per i non ebrei.
Quindi un clima che ricorda molto quello europeo e a tratti quello australiano, in cui ormai l’accoglienza sta cedendo il passo alla gelosia per i propri confini e per la propria nazionalità, anche nel caso in cui questo possa contrastare con le leggi di breve e lungo periodo del mercato, e dove la retorica criminale=migrante, favorita da alcuni partiti, sta divenendo convinzione dell’opinione pubblica generale, nonostante i numeri e la realtà dei fatti dicano tutto il contrario. Forse è proprio vero che la penna (e la parola) ferisce più della spada.