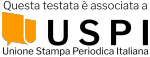“Salvare la vita ai pazienti è la gioia più grande. Ma la guarigione non dipende solamente dalle medicine, è fondamentale anche che io rassicuri i pazienti. Quello è il momento in cui sento davvero il loro cuore aprirsi verso di me.”
Evan Atar Adaha è il chirurgo vincitore del Premio Nansen per i Rifugiati 2018 che ha scelto di dedicare completamente la sua vita ai rifugiati.
Nel 2011 arriva a Bunj, Sud Sudan, dopo aver abbandonato l’ospedale in cui lavorava nello Stato del Nilo Azzurro a causa della guerra. Quello che trova al suo arrivo è un piccolo centro sanitario semi abbandonato.
Il dottor Evan Atar Adaha fornisce assistenza medica ai più bisognosi in una regione tesa e instabile del Sud Sudan.
Il dott. Evan Atar Adaha è capo chirurgo e direttore del suo ospedale, ma non ha un ufficio. Non gli piace sedersi.
Esegue fino a 10 operazioni al giorno, trascorrendo molte ore in piedi, e aiuta gli infermieri a preparare i pazienti e a controllare tutti, da quelli con ferite da arma da fuoco ai malati di malaria fino ai neonati.
Spesso è il primo ad entrare in sala operatoria, mettendo in posizione il tavolo di metallo pesante. Lo si può vedere all’opera nel reparto neo-natale, mentre parla dolcemente ai neonati. Recentemente un collega l’ha trovato che cantava a piedi scalzi sul tavolo operatorio mentre riparava la luce sul soffitto.
“Siamo qui per salvare vite umane, non per sederci”, dice il dott. Atar, che è conosciuto con il suo secondo nome. “Non c’è tempo di rilassarsi quando si è in sala operatoria. Siamo tutti uguali. Siamo tutti una squadra”.

Il dott. Atar, 52 anni, è il primo e unico chirurgo del Maban Referral Hospital, una struttura con 120 posti letto e due sale operatorie a Bunj, nella parte sud-orientale dello stato dell’Alto Nilo in Sud Sudan.
L’ospedale, a più di 600 km dalla capitale Juba, è l’unica struttura chirurgica funzionante nell’Alto Nilo e comprende una sezione neonatale e un reparto per malati di tubercolosi con 20 letti.
Aperto 24 ore al giorno, serve una popolazione di oltre 200mila persone. Il dott. Atar è così conosciuto che molti si riferiscono alla struttura chiamandola “l’ospedale del dottor Atar” e i pazienti viaggiano per giorni per poter essere curati da lui.
“Siamo il capolinea”, ci ha detto il dott. Kalisa Yesero Wabibye, un medico ugandese che lavora all’ospedale di Maban da più di due anni. L’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, finanzia il lavoro dell’ospedale attraverso diversi partner.
“Questa è l’ultima fermata prevista. Non c’è nessun livello superiore a cui inviare i casi più gravi. Non ci sono altri specialisti”.

Il dottor Atar e il suo staff lavorano in un ambiente difficile e pericoloso. Il Sud Sudan soffre di una forte carenza di strutture e di operatori sanitari qualificati, ed anche farmaci e attrezzature scarseggiano.
Quando il Sud Sudan ha ottenuto l’indipendenza nel 2011, contava circa 120 medici e 100 infermieri per una popolazione di 12 milioni di persone. Da quando è scoppiata la guerra civile nel dicembre 2013, provocando la migrazione forzata di oltre 4 milioni di persone, l’assistenza sanitaria è peggiorata.
In passato, le strutture mediche sono state saccheggiate e occupate e i membri dello staff sono stati intimiditi, detenuti, rapiti e assassinati. Le ambulanze sono state prese di mira e rubate. Dal 2013 sono stati uccisi 103 operatori umanitari.
La situazione nella contea di Maban è instabile e ci sono stati ricorrenti periodi di violenza negli ultimi anni. Dopo che gli uffici e le strutture delle organizzazioni internazionali, incluso l’UNHCR, sono stati attaccati a luglio di quest’anno, il dottor Atar ha continuato a lavorare nel suo ospedale anche quando i membri del suo team medico sono stati costretti ad andarsene.
Il dott. Atar minimizza il pericolo. “Qui ci prendiamo cura di tutti, indipendentemente da chi siano”, dice, e con un sorriso aggiunge che tutte le parti coinvolte nel conflitto sembrano comprendere che anche loro beneficiano di una buona assistenza sanitaria.
Con il suo inguaribile ottimismo, risate fragorose e talvolta un’evidente testardaggine, ha continuato a dedicarsi fedelmente alla causa di portare l’assistenza sanitaria ai più bisognosi.

Originario di Torit, nel Sud Sudan meridionale, il dott. Atar ha ricevuto una borsa di studio per studiare medicina a Khartoum e successivamente ha lavorato in Egitto.
Nel 1997, si è trasferito a Kurmuk nello stato del Nilo Azzurro in Sudan, nel cuore di un pesante conflitto durante il quale, spesso sotto i bombardamenti, ha diretto per dodici anni un ospedale di base che si prendeva cura di civili feriti e combattenti di entrambi i fronti.
“Quando sono arrivato, l’ospedale era in condizioni disastrose, l’unica cosa rimasta era un tavolo operatorio”, ricorda.
“Usavamo del filo normale per la sutura e dei bastoncini per il drenaggio del sangue.” Il suo bene più prezioso, dice il dott. Atar, è un set per l’amputazione e un piccolo kit di sterilizzazione datogli da un medico francese.
Nel 2011, sotto gli intensi bombardamenti che imperversavano in Sudan, lui e tutta la sua squadra si sono uniti a decine di migliaia di sudanesi in fuga attraverso il confine verso la contea di Maban nel Sud Sudan. Il dott. Atar ha caricato tutta l’attrezzatura del suo ospedale in quattro macchine e un trattore. “C’è voluto un mese”, ha detto parlando del viaggio. “Non c’era la strada. Era la stagione delle piogge. I fiumi esondavano”.

Nel 2011, la città principale di Maban, Bunj, era un piccolo villaggio con qualche negozietto. L’ospedale una volta era un centro di assistenza sanitaria di base senza sala operatoria. Per eseguire la sua prima operazione, il dott. Atar ha costruito una sala operatoria con un tavolo rialzato usando porte impilate una sopra l’altra.
Oggi, oltre a ospitare 53mila abitanti originari di Maban, l’area intorno a Bunj ospita anche 144mila rifugiati dello stato sudanese del Nilo Azzurro, di cui 142mila vivono in quattro campi per rifugiati. Inoltre ci sono 17mila sfollati interni sudsudanesi a causa del conflitto nella contea di Maban e nelle aree circostanti. Con l’intensificarsi dei combattimenti oltre confine, l’UNHCR si aspetta l’arrivo di altri 12mila rifugiati quest’anno.
Le strutture sanitarie nei campi sono collegate con l’ospedale di Maban. Il team chirurgico di quattro medici opera con una media di 58 casi alla settimana. Nel 2017, oltre il 70 per cento dei casi chirurgici riguardava persone rifugiate.
Bunj e le aree circostanti sono tese e instabili. Le comunità si scontrano per l’accesso a risorse limitate come il legno, lo spazio agricolo e i pascoli.
Il frequente riacutizzarsi delle tensioni tra i partiti politici porta a scontri a fuoco. Le agenzie umanitarie devono rispettare il coprifuoco e ripararsi dagli scontri a fuoco all’interno di bunker a prova di proiettile. In diverse occasioni, sono state evacuate a Juba. Il dott. Atar è sempre rimasto a Bunj.
Riconosce che la sua scelta di lavoro è stata dura per sua moglie e i loro quattro figli. Li vede solo tre volte all’anno. La famiglia vive a Nairobi e il dottor Atar cerca di tenersi in contatto con loro via WhatsApp ed e-mail diverse volte a settimana. “Ora posso fare i compiti di fisica e chimica con mia figlia maggiore”, dice. “Quando ero a Kurmuk, scrivevo lettere che impiegavano un mese per arrivare”.

Il dottor Atar non crede di star facendo qualcosa di straordinario. Vive in una tenda di tela, esposta alle intemperie, e tiene una macchina da cucire a pedale sulla sua veranda, che usa per realizzare teli chirurgici.
Dice che prende la sua energia dal latte che beve. Si rilassa la domenica andando in chiesa o facendo un pisolino all’aria aperta disteso sulla rete nuda di un letto arrugginito.
“È come avere l’aria condizionata”, dice. Ama cantare. A volte lavora con turni di 24 ore e gli piace scherzare sul fatto che le sue infermiere lo chiamano dittatore.
Mentre fa il suo giro, prende in giro i bambini, parla di pianificazione familiare con una madre che si sta riprendendo dal suo terzo cesareo, incitando un uomo con un braccio sinistro amputato e un femore destro distrutto a imparare a camminare usando una sola stampella, ed è chiaro che la sua fonte principale di felicità non deriva solo dalle operazioni che esegue, ma è connessa ai suoi pazienti.
Il dottor Atar, un cristiano che parla correntemente la lingua principale della regione, l’arabo, prega insieme ai pazienti prima che vengano sottoposti ad anestesia e, secondo la loro religione, recita la Bibbia o il Corano.
“Sono molto felice quando realizzo che il lavoro che ho svolto ha salvato qualcuno dalla sofferenza o gli ha salvato la vita”, ha detto. “Ma la guarigione non è la sola medicina. Devi rassicurare il paziente. Nel momento in cui ti metti in rapporto con un paziente, lui ti aprirà il loro cuore… Quando un paziente muore tra le mie mani, sono così triste”.
Parte del suo lavoro è l’improvvisazione. Se si presenta la necessità, specialmente durante la stagione delle piogge, quando la malaria è molto diffusa, raddoppia i pazienti nei letti e così riesce ad aggiungerne altri 60.
L’energia elettrica è fornita da due generatori e da pannelli solari. Il dottor Atar richiede a tutti i medici di avere abilità meccaniche di base. Sono state molto utili di recente, quando all’inizio di un’operazione tutti i sistemi si sono bloccati. Non c’è una banca del sangue. Qui molte persone credono che, se donano del sangue, moriranno. Il dottor Atar non ha remore a far pressione sui parenti di un paziente affinché donino il sangue.
Il dottor Atar dice che è improbabile che andrà in pensione. L’ospedale è ciò che dà speranza e significato alla sua vita. “Migliori sono i servizi che offri, più sono le persone che arrivano”, dice con una risatina.