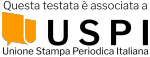L’aureo libretto che si presenta – La dignità dell’uomo, ed. Einaudi, 2021 – può a ragione considerarsi una delle pietre miliari della storia della filosofia occidentale. Fu redatto da Giovanni Pico della Mirandola nel 1486, a soli 23 anni di età, come premessa della discussione di 900 tesi, composte dallo stesso autore su filosofia e teologia, che si sarebbero dovute discutere pubblicamente in una riunione di dotti. La riunione non si tenne mai, anche perché alcune di queste tesi vennero condannate come eretiche, ma il possente torso dell’Oratio de hominis dignitate è per noi un vero e proprio manifesto del migliore umanesimo cristiano quattrocentesco.
Pico, infatti, è senza dubbio da annoverarsi tra i più originali pensatori di quel periodo ed è proprio sul termine “originale” che si è aperta una vexata quaestio tra gli interpreti. L’operetta, tanto breve quanto ricca di suggestioni e riflessioni, è permeata di una dottrina vastissima, di un travolgente entusiasmo, di una fulminea capacità di sintesi che l’ardore giovanile del Conte di Mirandola aveva vivificato con gli studi intensi e gl’intensi confronti con i pensatori più significativi, sia contemporanei sia della tradizione cristiana, ebraica e musulmana.

Al centro teoretico del testo campeggia lo stupendo apologo sulla natura e dignità dell’uomo; le due cose sono strettamente legate perché se l’uomo è un’ “opera dall’immagine indefinita” (indiscretae opus imaginis, pag. 7)), questa sua indeterminatezza, diremmo ontologica, è alla base della sua possibilità di abbassarsi “al livello delle creature inferiori…[o]…andare incontro a una rinascita tra le entità superiori” (pag. 9). Le due annotazioni, l’un l’altra richiamantisi, adombrano, dietro la loro apparente levità, questioni di estrema importanza e raffinatezza. Non solo si afferma il riconoscimento della libertà quale fondamento dell’essere umano, non solo brilla la totale assenza di qualsiasi riferimento al peccato originale, ma si manifestano anche gli echi delle meditazioni dei testi cabalistici, neoplatonici e aeropagitici impliciti in quel “superiora” così opportunamente reso con “entità superiori”.
Non passeranno nemmeno trent’anni dall’Oratio pichiana e sul concetto di peccato originale si divideranno definitivamente le strade tra Riforma e Umanesimo, segnando l’inizio di uno dei periodi più dolorosi della storia europea, caratterizzato dalle guerre di religione e dalla fine della Respublica Christianorum. All’incontro, per Pico questa indeterminatezza umana, che aggira la questione dello “status naturae lapsae”, nonché la ricchissima schiera di autori che fungono da riferimento, non sono al servizio di un sapere composto di mere nozioni teoriche, bensì i necessari presupposti per ciò che sta profondamente a cuore all’umanista: la concordia tra gli uomini.
Una concordia, una pace che può scaturire solo da una cultura vissuta in prima persona al di là della scolastica e dei suoi pseudo problemi, perché non serve a nulla “una conoscenza solo di seconda mano” (pag. 65, sapere solum ex commentario) mirante a soddisfare ambizioni e meschinità personali, forieri di conflitti tra uomini e nazioni. Se si vive un rapporto disinteressato con la cultura non si potrà che tutti convergere verso “l’unica Mente, che sta al di sopra di tutte le menti” (pag. 29, in una mente, quae est super omnem mentem) trovando in Essa pace e concordia.
Anche da queste brevi e forzatamente ridottissime indicazioni emerge la complessità delle questioni poste da Pico. L’attenta traduzione di Francesco Padovani sottolinea le molte implicazioni, tutt’altro che scontate, del pensiero del Conte. Dalla Kabbalah ai miti antichi, dal confronto con Ficino (ricordato in relazione agli scritti di Edgar Wind) alla profonda conoscenza della tradizione filosofica (compresi i filosofi arabi), questi aspetti sono ben evidenziati nella nuova edizione. Soprattutto, il commento e l’introduzione, a cura di Raphael Ebgi, sfuggono alla trappola che spesso ha ingabbiato molti studiosi: considerare Pico un precursore.
Questa interpretazione apparentemente esalta la figura del Conte, ma rescinde il rapporto strettissimo ch’egli ha col Cristianesimo e con le correnti culturali della sua epoca, mentre, in realtà, ne rimpicciolisce l’importanza perché viene a delinearsi solo in relazione a qualcun altro che è, lui sì, veramente grande (a scelta Erasmo, Pascal o addirittura l’attuale prometeismo). E’ questa la “vexata quaestio” di cui si è detto all’inizio e così si è potuto leggere Pico come antesignano di una modernità che gli è, invero, del tutto aliena.
Ci piace quindi ricordare, in chiusura, il bellissimo testo di Henri De Lubac, SJ, “Pico della Mirandola. L’alba incompiuta del Rinascimento” laddove il Conte viene posto all’interno del Cristianesimo umanista. Un umanesimo di cui tutt’ora si ha bisogno e a cui l’attuale Pontefice, profondo conoscitore di De Lubac, si ispira direttamente. La voce di Pico non si è dileguata, ma risuona ancora tra noi, nel nostro mondo stravolto dall’intolleranza fondamentalista (purtroppo non solo musulmana), con tutto il suo entusiasmo trascinatore, il suo ottimismo travolgente, il suo profondo amore per il sapere e per l’uomo.