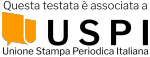L’attesa sa essere gestazione e partorire nuova vita.
Affinché ciò accada è inevitabile smarrirsi fra i cunicoli dei giorni, nelle ore di luce e in quelle di buio, rifuggendo l’oblio che tutto porta via, sottraendosi allo scialacquare delle parole dei bravi imbonitori, al turbinio degli eventi esterni, salvaguardando l’io e la sua inestimabile autenticità dal caos delle bocche che fagocitano aliti di vita.
Lasciare che il passato e il presente si sedimentino e si incontrino, seguendo le maree dell’esistenza del singolo che si intreccia con quella degli altri singoli. Farsi cantore, testimone, non nave in balia delle onde.
Non fermarsi nella rocca in attesa dei Tartari, non nascondersi dai fantasmi della nostra mente, temendo il confronto con il tempo che passa ma non lava via con la spugna nemmeno il più insopportabile dei giorni.
Solo attendere.
Già, ma attendere cosa? È il filo che lega la parola alle immagini in una attesa dolce che si ascolta in “Rebecca ascolta il mare” di Pierfranco Bruni per i tipi di Edit@. Dunque l’attesa.

Attendere che il cuore, l’animo, la mente e gli orecchi siano protesi nella direzione in cui il vento soffia e parla di soppiatto. Attendere il momento e afferrarlo.
Lasciare che l’attesa diventi arte, significa, allora, attendere che il percorso del poeta segua la via che egli ha tracciato con la penna e le sue azioni, rintracciare l’incastro perfetto che giunge e travolge, donando nuova linfa e ispirazione.
A volte, quell’incastro con la realtà contingente è il sorriso straripante di gioia di una bambina con gli occhi grandi e incendiati di fulgida curiositas, incorniciati dai suoi riccioli di rame che ricordano le onde al tramonto.

Nasce Rebecca.
Nasce così un nonno.
Nasce Rebecca ascolta il mare.
E il nonno ascolta Rebecca, con gli orecchi e con l’animo. L’ascolta mentre emette i suoi primi versi, mentre articola i primi tentativi di parola. L’ascolta mentre le parole, a volte, diventano urla contro un mondo che non è fatto a misura sua, un mondo di cui il nonno vuole narrare.
In realtà, l’ha già narrato. L’ha fatto nei tempi in cui sua madre e suo zio erano piccoli scopritori del mondo come lei. Ma ora, quel mondo, così cambiato e così turbolento, suo nonno lo esplora attraverso di lei.
Così egli scrive di nuovo. Non solo. Rimette mano a quei vecchi versi lasciati nel cassetto. Non sono stati lì a prender polvere quei fogli. Sono stati lì a decantare, come si fa con il buon vino. Hanno atteso la loro occasione.
Rebecca ha ridato a suo nonno la chiave per aprire quel cassetto e la sua storia si è mescolata a quella di tanti altri bambini che procedono empiricamente nei loro passetti verso la conoscenza della realtà e urlano contro i mostri che la popolano.
Quei fogli, allora, sono diventati un libro e quel libro è stato presentato sull’infrangersi delle onde contro il castello di antiche memorie e di antiche amicizie che, come quei versi, hanno atteso di riconoscersi negli occhi e nelle inscalfibili memorie.
La silloge si apre con una poesia, una dedica, un’unica sestina di versi liberi ispirata da Rebecca, musa e al contempo cantrice, <<sguardo infinito della bellezza>>, capace di incarnarsi favola. Una favola, però, che non illude come quella di Ermione dai vestimenti leggeri, ma che ha nello sguardo lo stupore delle prime volte che diventano perpetue realtà, seppur filtrate da un <<oblò di sogni>>, come si legge nella lirica I della prima sezione “I bambini ascoltano”.
Ebbene, se già dalla lirica I emerge un apparente baratro fra il mondo degli adulti, schiavi della frenesia quotidiana e dell’egotismo, <<sconfitti e lacerati dai dubbi>>, <<venditori di fumo/nella celebrazione delle ovvietà>> in un baratro in cui Rebecca, in rappresentanza dei suoi colleghi-bimbi, si fa ponte, il vero distacco fra mondo il Noi, gli adulti e il Voi, i bambini emerge nella lirica V.
In essa, la celebrazione dei sorrisi gioiosi e dello sguardo che passa in rassegna il mondo circostante della lirica II lascia il posto alla barbarie più crudele: la sottrazione dell’infanzia all’umano. Un umano a cui l’infanzia è stata rubata sarà sempre un umano a metà, monco, incapace di adattarsi alla perfezione, costretto a vacillare anziché camminare fra i corridoi della vita.
Un primo verso che potrebbe essere titolo: l’infanzia negata. Esso confluisce poi nel secondo, mediante enjambement, e rende evidente il massacro quotidiano, probabilmente di corpi in guerra, e di anime nell’agitazione del quotidiano. Un massacro che nell’ossimoro del terzo verso si concretizza nell’invisibilità di un <<silenzio urlato>>, che porta a indossare una maschera per soffocare i dolori, per sopprimere il peso dell’anima, non più lieve come una piuma, ma già pesante come macigno, nonostante i pochi passi fatti su questa Terra. Una maschera catartica, come quelle del teatro antico. E a questi bambini, stretti nella morsa dell’indifferenza degli adulti, rei di averli messi al mondo per poi lasciarli allo sbando, non rimane altro che un ultimo disperato tentativo per tenersi a galla: giocare a <<inventarsi adulti>>.
Inventarsi, già. Perché non puoi che inventare se non conosci, se non ti è stato fatto regalo dell’ascolto. Perché i bambini, come già detto nella lirica II dal poeta, non dimenticano.
È proprio per bambini come questi, ignorati e malmenati dalla vita, che <<vivono di solitudini/nella nebbia e dell’alba>>, dilacerati dal dolore imposto loro dalla furia violenta della guerra dei grandi, che il poeta dedica, in un altro componimento, una preghiera laica. Tramite un complemento di vocazione, Bruni si rivolge direttamente a Cristo, colui che per primo, sulla croce, avrebbe patito e colui che avrebbe radunato attorno a sé i bambini, i figli del padre suo, fratelli suoi stessi. <<Cristo/togli loro/l’amarezza e lo sconforto>>.
I bambini… Sono loro, quasi faro nel mare in tempesta, che vengono scorti da lontano, su quella nave di aquile albanesi, di volti bruni che guardano la riva con l’animo inquieto, <<che chiedono attesa>>, la stessa attesa che germoglia nelle pagine di questo libro.
Bruni si fa così voce di infinite variazioni di esistenza, della combinazione fra la sua infanzia dal profumo di tigli, fra il sé bambino mai davvero scomparso, passeggiante nella memoria e quindi vivo nella sua essenza, i piccoli albanesi e orientali che lasciano la propria terra e Rebecca e suo zio che sorridono e chiedono di essere colti nell’attimo fugace di donare le proprie tesserine perlate al nonno e al papà.
Ed è così che si scivola fra le pieghe della sezione “I bambini non dimenticano” che, a differenza della precedente, ha titoli-parola, non titoli-enumerazione di una successione in un piccolo poema.
Lo aveva già annunciato, il poeta, che i bambini non lasciano che l’oblio prenda il sopravvento, ma si era anche contraddetto, nel gioco della poesia, della descrizione dei piccoli che hanno lasciato l’Oriente e che hanno dimenticato. Ma sarà vero che essi hanno dimenticato? Il poeta, non dice, forse, che essi non sanno farlo? Non ha forse realizzato una sezione dal titolo “I bambini non dimenticano”? Bruni ha forse dimenticato i tigli e i meriggi figli del vento? No. Non dimenticano. I ricordi hanno sede profonda, nel cuore. Ma la penna ha voluto essere indulgente, forse creare una piccola ucronia in cui quei bambini, scappati via dall’Oriente speziato e spezzato, hanno saputo seppellire i ricordi sotto una coltre di coperte, regalandosi la possibilità della quiete, mentre le loro madri, che volgono loro lo sguardo ansiose, tanto ricordano quelle avvolte dagli scialli di qualche componimento dopo, in una costruzione del testo quasi geometrica.
La fenomenologia dell’amore che è Rebecca ascolta il mare si fa ricerca ontologica e metafisica, in cui si fanno strada, tra gli interrogativi, Alessandro, Irina, Paulo, Ismael, Andrea e Manuelito. Echi di vita che si incarnano negli occhi folgoranti di Irina ma anche nella pelle bruciata dei fanciulli.

Ma se qui i bambini non dimenticano, nella sezione seguente essi ricordano.
Dalla passività del ricordo che si insinua nella mente e vi si aggrappa per non lasciarla più al gesto attivo del rimembrare, sospinto dalla volontà di conoscersi memoria e di narrarsi a sé, in primo luogo, e poi agli altri con lo sguardo, di farsi <<echi di una strada>>.
Ulteriori due sezioni, di cui una particolarmente breve per numero di versi e di componimenti, e infine quello nata assieme a Rebecca. La prima stropiccia. Stropiccia l’animo del lettore, quasi lo accartoccia. Componimenti quelli di questa sezione ermetici per lunghezza e mistero, che lasciano il posto alla gioia di scoprirsi uomo e ancora fanciullo (Quel fanciullino pascoliano!).
Nell’ultima sezione si scopre un amore nuovo, infinito, che ha etimologia ebraica, come lo anche quello della madre e significa “ruscello”. Rebecca, da Ribqàh, colei che avvince con le sue grazie. Un nome che è garanzia. Rebecca ha avvinto al suo il cuore del nonno e lo ha fatto con le guance paffute e tenere dei suoi primi mesi di vita, con gli occhi della bisnonna e la grazia di chi cammina sfiorando una terra ancora troppo aspra per lei. Ma è un amore, questo, che ha anche il nome del poeta di Mantua, che è in fondo il nome del padre e del figlio di Bruni dal <<sorriso della bellezza di tua madre>>. Un nome, il loro, che ha anche esso etimo assai curioso e convincente, benché incerto: l’uomo puro come un giglio. A quest’uomo puro, all’epoca bambino non scalfito dalla vita, il poeta regala un ammonimento: <<Viviti! […] La vita è in te>>.
Se a chiudere la raccolta sono le parole che danno il titolo all’intero libro, l’attenzione rimane incastrata fra tre versi che risuonano con la vigorosa gioia di una tripla dichiarazione d’amore:
Sei tua madre/con lo sguardo di mia madre./Punto!
Una ring composition o un chiasmo di ampio raggio ben calibrati quelli di Rebecca ascolta il mare:
Si inizia con Rebecca e con Rebecca si chiudono le pagine, i titoli della prima sezione sono numeri romani e quelli degli ultimi numeri cardinali, come cardinali sono nella memoria e nel viaggio di Ulisse, che è il nostos del poeta, le persone che la popolano.
Sia fatta allora lode all’arte dell’attesa e ai libri decantati e che poi trovano il tempo di sbocciare come ginestra nel deserto.