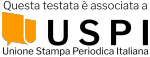La caduta del muro di Berlino, nel novembre del 1989, ha segnato una profonda “rottura di civiltà” – ha scritto nel 2003 Jean Daniel, fondatore de Le Nouvel Observateur – non come l’11 settembre. Prima degli attentanti alle Twin Towers sapevamo tutto, ma non sapevamo che gli Stati Uniti avrebbero potuto essere aggrediti nelle loro “ville debout!” – la “città in piedi” così definita da Céline nel suo Viaggio al termine della notte del 1932 – simbolo occidentale del progresso e ignoravamo cosa potesse nascere dall’intensità di quel trauma nell’anima dell’America profonda: le guerre.Due guerre ancora più inedite che vanno a scontrarsi con teorie e schemi appartenuti al passato, da Clausewitz in giù.
Il 7 ottobre 2001 la Casa Bianca e i suoi alleati sferrano l’attacco al regno dei Taliban dove si nasconde Osama Bin Landen, la battaglia è vinta ma i risultati non sono quelli sperati. Poi toccherà a Bagdad nel marzo del 2003, ma il copione si ripete: cade Saddam Hussein ma la violenza continua. Guerre iniziate sotto George W. Bush, proseguite sotto Barack Obama – la sua America ha fatto però centro, uccidendo Osama Bin Laden nel maggio del 2011 – e terminate da Joe Biden con il confuso e quanto mai poco meditato ritiro da Kabul in questo caldo agosto del 2021. Sono passati vent’anni da quell’11 settembre e il mondo, così come lo conoscevamo e comprendevamo, è davvero cambiato. Ci sentivamo sicuri e lanciati verso un futuro di grandi propositi. Siamo ripiombati in un pozzo di nuove e vecchie angosce, tra attentati strazianti, guerre roboanti e diritti civili sempre più stracciati. Per chi ha dimenticato e chi non era ancora nato facciamo un passo indietro e riavvolgiamo il nastro della storia che, fatalmente, ama riavvolgersi e tornare al punto di partenza, anche quando non è un bel partire.
Il primo aereo. Alle 8:46 del mattino, il volo American Airlines 11 romba in direzione sud nel cielo sopra Manhattan, attraversando l’isola in tutta la sua lunghezza e sorprendendo chi camminava per strada, prima di schiantarsi contro la Torre Nord, conosciuta come World Trade Center 1, a circa 465 miglia orarie». David Kravette, broker di borsadella Cantor Fitzgerald, Torre Nord: «Il fatto che io sia vivo è un puro caso del destino. Quel giorno tutti i miei colleghi su in ufficio hanno perso la vita. Erano intrappolati, non c’era modo di uscire».
Il secondo aereo. Alle 9:03, il volo United Airlines 175 si schianta contro la Torre Sud, WTC 2, a circa 590 miglia orarie». Capitano Jay Jonas, unità di soccorso: «Ero lì in piedi. Come si può immaginare c’era un gran chiasso, l’acustica nell’atrio del World Trade Center non era delle migliori, c’era molta eco. Poi, tutto d’un tratto, calò il silenzio. Uno dei vigili del fuoco della squadra speciale Rescue 1 guardò verso l’alto e sentenziò: “Potremmo non arrivare a domani”.
Scuola elementare Emma Booker, Sarasota (Florida): Andrew Card, capo di gabinetto della Casa Bianca. «Stavo recapitando un messaggio che nessun Presidente vorrebbe mai ricevere, lo sapevo: “Un secondo aereo ha colpito un’altra torre. L’America è sotto attacco.” Ho fatto qualche passo indietro in modo che il presidente George W. Bush potesse farmi domande».
Il terzo aereo. Alle 9:37, il volo American Airlines 77 si schianta contro l’Ala 1, la parte occidentale del Pentagono, a 530 miglia orarie».
Dentro le Torri e poi il vuoto. Bill Spade, vigile del fuoco della squadra speciale Rescue 5, FDNY: «Nella Torre Nord c’erano delle porte automatiche, che continuavano ad aprirsi e chiudersi per i corpi che cadevano giù». William Jimeno, agente della PAPD: «Una persona mi ha colpito più di tutti, era come se potessi concentrare lo sguardo solo su di lui: era un signore biondo con i pantaloni color cachi e la camicia rosa tenue. Si gettò da lassù, e quando lo fece ricordava quasi Gesù sulla croce, dalla posizione, perché mentre precipitava era rivolto verso l’alto».
Il primo crollo. Alle 9:59, dopo nemmeno un’ora dall’attacco la Torre Sud, il secondo obiettivo colpito, collassa cedendo alle fiamme alimentate dalle migliaia di litri di carburante contenute nel velivolo. Bruno Dellinger, presidente della Quint Amasis North America, Torre Nord: «Su di noi calò l’oscurità con una violenza incredibile, non c’era alcun rumore. I suoni non riuscivano più a propagarsi perché l’aria era troppo densa».
Il quarto schianto. L’unico dei quattro a non aver raggiunto il suo obiettivo, schiantandosi in un campo vuoto vicino Shanksville (Pennsylvania), destinato probabilmente al Campidoglio o alla Casa Bianca.
Il secondo crollo. Sharon Miller, ufficiale della PAPD: «C’era un grande silenzio, come se tutto fosse coperto di ovatta».
I numeri della tragedia: 3000 vittime, 246 nei cieli sui 4 voli dirottati esclusi i 19 terroristi, 2700 dentro le torri di cui 1400 solo nella Torre Nord, 411 i soccorritori di cui 343 erano vigili del fuoco di New York, 10mila i frammenti di ossa e tessuti rinvenuti e non identificati.
Oggi, a vent’anni dall’11 settembre, la storia si raggomitola su sé stessa e si ripete nella sua forma più tragica, come dalle Twin Towers abbiamo visto corpi di donne e uomini che cadono nel vuoto dell’indifferenza occidentale. Le immagini “inchiodano” l’Occidente alle sue responsabilità e “parlano” più dei fiumi di parole della diplomazia. I talebani hanno ripreso il potere in un ferragosto infuocato, Kabul di fatto si è consegnata ai “terroristi in motocicletta”.
I diritti umani sono stati evacuati frettolosamente nell’ambito di quello che verrà ricordato come il primo e cocente “fallimento” in politica estera di Joe Biden. Il tramonto dell’uguaglianza e il trionfo della barbarie, secondo il New York Times l’evacuazione degli americani da Kabul riflette la storia di vent’anni di guerra segnati dalla disconnessione tra la diplomazia americana e la realtà sul terreno.
L’Afghanistan oggi come il più appetibile degli “Stati falliti” dove l’Isis può risorgere attraverso obiettivi molto più feroci della vecchia Al Qaeda, la guerra jihadista è iniziata e il ritiro dell’Occidente è stato fragoroso.
“Occidente” nella sua accezione storica ossia ambito definito dall’appartenenza alla civiltà e cultura europea, contrapposta a quella dei popoli del Medio ed Estremo Oriente; nel periodo della guerra fredda, i paesi a democrazia parlamentare e a economia liberistica in contrapposizione ai paesi comunisti dell’Europa orientale e dell’Asia e ai loro caratteri culturali, economici e sociali.
Del resto, come già teorizzato dal politologo statunitense Samuel P. Huntington nel suo Lo scontro delle civiltà del 1996, nel mondo post-Guerra fredda le principali distinzioni tra i vari popoli non sono di carattere ideologico, politico o economico, bensì culturale. Le linee di faglia tra le civiltà saranno quelle sulle quali si consumeranno le battaglie del futuro, popoli e nazioni tentano di rispondere alla più basilare delle domane: chi siamo? I principali raggruppamenti di Stati non sono più tra i tre blocchi creati dalla Guerra fredda ma le sette-otto maggiori civiltà del globo (per Huntington: Occidentale, Latino americana, Africana, Islamica, Sinica, Indù, Ortodossa, Buddista, Giapponese). Oppure, come affermava Henry Kissinger nel 1994 nel suo Diplomacy: “Il sistema internazionale del XXI secolo conterà almeno sei grandi potenze – Stati Uniti, Europa, Cina, Giappone, Russia e probabilmente India – e una miriade di paesi piccoli e medi”.
Occorre “un’attenta riflessione per capire come mai l’America si sia ritrovata a dare l’ordine del ritiro, con una decisione presa senza preavviso né accordo preliminare con gli alleati e con le persone coinvolte in questi vent’anni di sacrifici. E come mai la principale questione in Afghanistan sia stata concepita e presentata al pubblico come la scelta tra il pieno controllo dell’Afghanistan o il ritiro totale”. Lo ha scritto pochi giorni fa Henry Kissinger in un intervento sull’Economist pubblicato dal Corriere della Sera dopo “la riconquista dell’Afghanistan da parte dei talebani”. Da questa analisi bisogna ripartire per capire cosa sta succedendo e cosa succederà nello scacchiere geopolitico dell’area. Probabilmente si definiranno nuove trame di supremazia globale.
Come ha scritto il giornalista britannico Gideon Rachman “la fine di Kabul potrebbe rappresentare l’inizio del mondo post-americano”, nella capitale afghana le “chiavi della supremazia globale” ha affermato Robert D. Kaplan sul The Spectator.
Il ritiro dall’Afghanistan segna il declino dell’impero americano, momentaneo o duraturo lo scopriremo presto, così come è chiara ormai l’ascesa della Cina e della Russia. Di fatto l’uscita di scena delle truppe statunitensi ha conseguenze geopolitiche per l’Asia centrale che ha avviato da tempo un processo che la porterà a diventare un insieme organico, all’interno del quale l’Afghanistan, le ex repubbliche sovietiche e la provincia cinese dello Xinjiang si influenzeranno sempre più.
Un’area posta al centro della Belt and Road Initiative BRI cinese: opera audace di collegamento all’Europa e all’Africa Orientale, volta al miglioramento della cooperazione tra i Paesi dell’Eurasia attraverso l’apertura di due corridoi infrastrutturali fra l’Estremo Oriente e il continente europeo, nel solco delle antiche “Vie della Seta”, uno terrestre (Silk Road Economic Belt) e uno marittimo (Maritime Silk Road). La BRI si spingerà a sud attraverso il Pakistan verso il porto di Gwadar, costruito dai cinesi sull’Oceano Indiano, questa via potrebbe includere l’Afghanistan pacificato. Insomma, aumentano le chance della Cina di prendere il controllo dell’Heartland, “isola-mondo” teorizzata da geografo inglese Sir Halford Mackinder, espressione coniata per indicare l’Eurafrasia, che nella sua teoria presentata nel 1904 alla Royal Geographical Society affermava: “Who rules East Europe commands the Heartland: who rules the Heartland commands the World-Island: who rules the World-Island commands the World”. Così come di acquisire per Pechino il Rimland, fascia marittima e costiera che circonda l’Eurasia, definizione dello studioso statunitense Nicholas John Spykman, che negli anni trenta rivisitò la geopolitica come era stata concepita da Halford Mackinder. Ritirandosi dall’Afghanistan Biden ha scelto la linea costiera rispetto al “cuore del continente”, tuttavia le due aree sono destinate a fondersi e molto dipenderà dall’Afghanistan.
La Russia non rimarrà a guardare, considerando che il russo è ancora una lingua franca in gran parte dell’Asia centrale e il vantaggio dei servizi segreti russi nell’area rispetto ai cinesi è considerevole. E gli Stati Uniti? Secondo alcuni osservatori per non perdere completamente il controllo dello scacchiere asiatico Biden dovrebbe impostare una strategia diplomatica ed economica solida e ben definita, di modo che nessuna delle due superpotenze acquisisca il controllo dell’Asia centrale. Altrimenti la Cina potrebbe finire per dominare l’”isola-mondo”.
Finché non sarà chiaro se i talebani siano in grado di governare il paese assisteremo a un gioco attendista, solo dopo inizierà il futuro.
«Figurez-vous qu’elle était debout leur ville, absolument droite. New York c’est une ville debout. On en avait déjà vu nous des villes bien sûr, et des belles encore, et des ports et des fameux même. Mais chez nous, n’est-ce pas, elles sont couchées les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves, elles s’allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur, tandis que celle-là l’Américaine, elle ne se pâmait pas, non, elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur». Louis-Ferdinand Céline, Viaggio al termine della notte, 1932