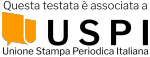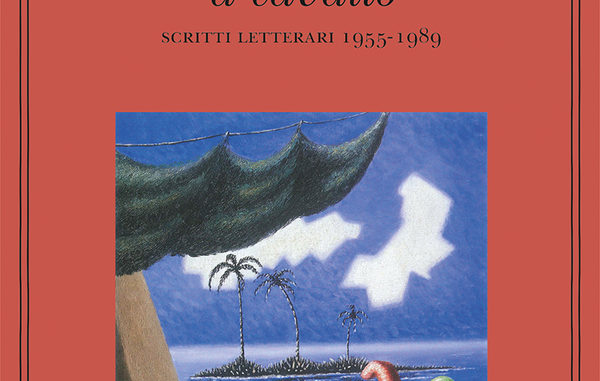
Appare da Adelphi, presso la quale viene ripubblicata l’intera opera di Leonardo Sciascia, la raccolta – da giornali e riviste – di saggi letterari (1955-1989) intitolata Fine del carabiniere a cavallo (MI, 2016, pp. 246) e curata, con filologica acribia, da Paolo Squillacioti. Il curatore precisa in appendice che la raccolta non esaurisce tutti gli scritti saggistici di Sciascia, esattamente come accadde per Alberto Savinio, per il quale lo stesso Sciascia asseriva: “bisognerà raccogliere tutti i saggi, tutti gli articoli, per avere veramente tutto Savinio e rendersi conto che si tratta, dopo Pirandello, del più grande scrittore italiano di questo secolo” (curando personalmente una collazione di ‘scritti dispersi’, Bompiani, 1989). Ma è noto l’amore che Sciascia nutrì verso il fratello di De Chirico e che una nota editoriale riconduce a quello stendhalismo – nel senso di ‘dilettarsi della vita’ – che abbina entrambi gli scrittori.
Come spiega Sciascia nel primo saggio della raccolta, la fine del carabiniere a cavallo è da collegarsi a quel ‘richiamo all’ordine’ che rondisti e post-rondisti, al tempo del famigerato biennio rosso, facevano di quel simbolo, mentre già i fascisti nelle piazze “agitavano il manganello per instaurare l’ordine”. E aggiunge: “Dobbiamo riconoscere che, connivenza o meno, il carabiniere a cavallo, questo splendido simbolo dell’ordine – blu rosso e argento – era già fascismo”. Fine che Sciascia situa con la pubblicazione della vittoriniana Conversazione in Sicilia, attraverso quel processo di rieducazione al realismo degli scrittori americani (si ricordi l’antologia Americana del 1941/42), dell’esperienza della guerra civile spagnola e di un ritorno a Verga e, più indietro, a Belli e Porta.
Il richiamo al realismo e alla prosa romanzesca, che “è già dalla parte della storia”, ci porta al secondo saggio sulla narrativa del primo Calvino. Perché Calvino “è fedele alla storia: e sotto il libero e felice trascorrere della sua fantasia o della sua memoria (ma anche la fantasia in Calvino è memoria) c’è sempre un preciso e radicato senso della storia”. Seguono in questa sezione saggi su Edward Morgan Forster; su Lawrence Durrell (nel quale, per incidens, Costantino Cavafis è detto “il più grande poeta della Grecia moderna”); su Giovanni Arpino (la cui Suora giovane scavalca la tradizione romantica ed è paragonata al contadino maschio che si fa carabiniere per sfuggire a una misera condizione). Ma è il saggio sull’Ulisse di James Joyce, uscito finalmente in italiano (1960) che appare troppo riduttivo, perché Sciascia fa rientrare il lavorio linguistico del romanzo nella “ipertrofia linguistico-erudita dei padri gesuiti” e ritiene che l’autore è uno degli “scrittori che non sono più cattolici e scrivono in funzione del non esserlo più”. Concludendo che non gli interessava la “cattolica disperazione di Joyce”, anche se tentava di intenderla. Al contrario è molto positivo il saggio su Il ponte sulla Drina di Ivo Andric, perché egli “crede nella ragione degli uomini: e se racconta la storia di un luogo e di un tempo in cui la vita fu inconsciamente ragionevole, in grazia di quel ponte gettato tra le due sponde dalla Drina, tra l’oriente e l’occidente, è perché crede che il mondo intero può diventare, coscientemente, il luogo della ragione”. La sezione si conclude con le notazioni sui Racconti di Tomasi di Lampedusa, per noi molto più interessanti, conoscendo gli “an-
tecedenti” e le polemiche nate quando uscì Il Gattopardo. Qui Sciascia parte da una considerazione di Tomasi, sulla rilettura dell’Henry Brulard di Stendhal (considerato il suo capolavoro), in cui è detto che, al contrario del francese che “interpretava la sua infanzia come un tempo in cui subì tirannia e prepotenza, per lui l’infanzia è un paradiso perduto”. E vede perciò in Lighea una “fissazione” (come in psicoanalisi aveva fatto Basilio Reale in Sirene siciliane, Sellerio, PA, 1986) nel passato, e cioè un apologo della decadenza. Preferendo comunque il racconto allo stesso Gattopardo.
La sezione successiva è intitolata dal curatore Divagazioni sulla storia e la cultura europea. Inizia con un importante saggio già apparso su “Officina” nel 1956, poi ripreso in La noia e l’offesa, l’antologia sul fascismo e gli scrittori siciliani curata dallo stesso Sciascia (Sellerio, PA, 1991), intitolato La sesta giornata (quella con cui a Milano si alludeva a “coloro che passata la tempesta delle cinque giornate uscirono di casa armati e incoccardati”). Vi si parla dell’“avvenimento nodale” che fu nella formazione di Sciascia la guerra civile spagnola e, per quanto riguarda la nostra Resistenza, che “abbiamo avuto una poesia sulla Resistenza ma non della Resistenza” (e che perciò essa resta da sesta giornata). Seguono saggi su Alexandre Dumas (il “briccone” che reincontrando Garibaldi a Milazzo si era fatto retribuire profumatamente i 1500 fucili che asseriva avergli comprato con i suoi risparmi, come riferisce il cappellano militare Giuseppe Buttà in Un viaggio da Boccadifalco a Gaeta, Bompiani, MI, 1985); su Herbert Marcuse (per il saggio Controrivoluzione e rivolta, sul “pericolo che la rivoluzione entri e venga assorbita nel suo contrario”); su un incontro tra Giacomo Casanova e Voltaire (a proposito della lettura dell’Orlando furiosonouveaux philosophes (in cui è richiamata la polemica sul coraggio e la viltà degli intellettuali); sulle “voci” di un “dizionario, una specie di schedario della memoria” (la prima, su Montecitorio, afferma: “Al contrario che nel regno di Dio, in una repubblica democratica molti sono gli eletti, pochi i chiamati”; altre “voci”, e altre preferenze di Sciascia sono più note, come quelle su Borges e sui “cretini”).
La sezione continua con un saggio su Giraudoux e Pirandello, dove alla “piacevolezza” del primo Pirandello contrapponeva una “letteratura non di sole parole, ma di cose”; uno su Unamuno – durante una visita all’Università di Salamanca – nel quale vengono messe in luce le sue “contraddizioni” e donchisciottismo per l’adesione al franchismo; un saggio su “le due Sicilie” di Lernet- Holenia e Andrzej Kusniewicz; uno che riprende il tema del ‘pirandellismo’ e della ‘corda folle’ (la follia aveva condotto un uomo a introdursi in un convento di Racalmuto per quattro volte); uno su un sonetto del Belli basato sull’impunità che nello Stato pontificio corrisponde per Sciascia all’odierno pentitismo; uno sulla paura dell’Aids che richiama quella per la lebbra in un racconto di Buzzati; uno che prende spunto dal famoso pamphlet di Julien Benda La trahison des clercs per affermare che “l’intelligenza può non essere vinta, ma a patto che di fronte al potere sia professata e affermata da chierici e non da sagrestani: […] le epoche in cui l’intellettuale ha davvero un ruolo […] sono quelle appunto in cui l’intellettuale non si interroga sul proprio ruolo, non teme rifiuti e processi, corre come freccia al bersaglio”; un saggio sul Tour en Sicile, 1833 del barone Gonzalve de Nervo, ennesimo “viaggiatore straniero in Sicilia”, scritto con “leggerezza, per coloro che nella vita di un uomo cercano le ore gradevoli e non la gravità dello studio. Idea che potremmo dire stendhaliana”; e infine uno sui mutamenti d’animo di Stendhal nell’assistere alla trasformazione in ‘tiranno’ di Napoleone e prefigurante una unità europea ‘laica’: “che cominci da quanto di più laico ci sia nel patrimonio della storia degli uomini, e cioè dal diritto”.
La terza e ultima sezione concerne dieci “ritratti” di scrittori contemporanei (G.A.Borgese, Longanesi, Savinio, Brancati, Montale, Soldati, Morovich, Bufalino, Rugarli e Consolo). Non si può qui dar conto di tutti e conoscendo già le predilezioni sciasciane per Borges, Savinio e Brancati, si accenna soltanto a uno di questi (uno per tutti). Quello su Montale, che Sciascia dice di aver conosciuto tramite l’amico libraio siculo-milanese Manusé (sul quale si possono ricordare, su questo giornale, quanto detto nei nostri articoli del 11 gennaio e 3 settembre 2015). Lo scrittore ne parla con “gratitudine” perché, insieme con Moravia, erano gli unici che, durante il fascismo, “non soltanto non adulavano, non elogiavano, non mostravano simpatia: erano, in tutto quello che scrivevano, assolutamente diversi da quel che in Italia si acclamava e si imponeva, assolutamente estranei”. Per poi concludere: “La grandezza di Montale sta in questo: che nelle sue non molte pagine è racchiuso, come nelle molte di Pirandello, il dramma del nostro tempo, il male di vivere del nostro secolo. […]
Quel che Montale allora viveva, noi l’abbiamo vissuto negli Anni Quaranta. Il suo segreto ora è il nostro. Che è il segreto della grande poesia: quella che antivede, che ci dà notizia di noi stessi – quella che ci fa “voltare”.
Si può anche non condividere, o discutere, alcune opinioni espresse da Sciascia in questo ricchissimo libro (e derivanti da quelle che il curatore chiama “idiosincrasie estetiche e ideologiche”). Ma una cosa è certa: non si può non restare ammirati dall’esercizio della sua intelligenza.
Leonardo Sciascia, Fine del carabiniere a cavallo, Adelphi, MI, 2016, € 23,00.