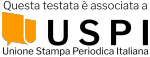I cinquantennali sono ricorrenze ghiotte. Lo so bene: quest’anno compio mezzo secolo e, tre anni fa, ho dedicato un libro ai 50 anni della rivista “Linus”.
Pare quasi che il pubblico, forse un po’ annoiato dal presente, non veda l’ora di ricordare momenti epici e topici verificatisi 10, 20, 30… 50… 100 anni prima.
In questo maggio 2018, confusi e infastiditi dalla roulette russa governativa, oscilliamo sull’incerto bilico tra la commemorazione del mezzo secolo delle rivolte del 1968 (e sotto il pavé la spiaggia, la fantasia al potere, siate realisti chiedete l’impossibile, …) e i 40 anni della tragica uccisione di Aldo Moro.
La libreria non è un tempio e il libro non è una reliquia. Il cliente che varca la soglia di quel negozio, dotata di allarmi antitaccheggio, sa di essere in un mercato alla ricerca di merce. La mia ultima spesa mi ha garantito una sorpresa: l’editore Raffaello Cortina, cavalcando l’opportunità del cinquantennale, ha portato sui banchi Maggio ’68: la breccia di Edgar Morin. Un libro importante perché, come sappiamo, il sociologo è stato l’unico intellettuale francese capace di tradurre in cronaca le impressioni estemporanee raccolte nelle università durante quel maggio parigino esplosivo. Le ha trasformate in articoli per i quotidiani e si è accollato l’onere di un’analisi in presa diretta.
Morin ha scritto cose scomode e fastidiose e ha rischiato grosso. La storia, per essere raccontata, ha bisogno di distacco temporale ed emotivo. Gli snodi, che rendono evidente lo sviluppo del processo, devono essere valutati in termini di cause e di effetti, perché, come dice Carlo Ginzburg, “raccontare la Storia è, anche e soprattutto, raccontare una storia”. Raccontare gli effetti di un fatto mentre quello sta accadendo richiede la capacità di leggere il volo degli uccelli, le viscere degli animali e il fondo del caffè. Quando i fatti non causano effetti, non può esserci storia. Senza fabula, il racconto crolla: gli intrecci si sfilacciano e il mondo, in quel tappeto consunto e pieno di buchi, non ci sta più.
Come dicevo, ho dedicato un libro alla rivista “Linus”: un’analisi dei primi anni di quel mensile che usa un periodico dedicato ai fumetti come prisma attraverso cui guardare gli anni Sessanta del Paese. Per farlo, e per il personalissimo piacere di ascoltare storie, ho intervistato alcuni dei protagonisti di quel periodo. Uno di questi è un importante professore universitario, un anziano signore la cui cultura vastissima è intrecciata fittamente a una straordinaria capacità critica. Mi stava raccontando il suo ’68 e gli ho chiesto quale fosse la sua posizione a posteriori. Con voce e corpo sottili, piegandosi in avanti e strizzando un po’ gli occhi, il professore mi ha risposto: “Lei questo non lo scriva, ma a me pare che senza il ’68 avremmo visto molti meno topless e io sono felice che ci sia stato”.
In mezzo a quel racconto, quella frase, detta sorridendo e ammiccando, mi era parsa una boutade. Poi ho sbobinato l’intervista e ho riletto quelle parole sulle pagine del mio quaderno. Mi perdoni ancora, professore, devo scriverlo.
Avremmo visto meno topless. È vero. La liberazione dei corpi, la consapevolezza della matericità delle carni, il peso della pelle che invecchia, … Il ’68 ha messo al centro del discorso politico e sociale la fisicità degli individui che muovono il proprio corpo nel tempo e nello spazio. In un’appendice alle sue analisi giornalistiche, Morin sottolinea l’esistenza di un prima e di un dopo. Prima del maggio 1968, i giornali femminili raccontavano di come tenere in ordine la casa, accudire i figli e fare piacere al marito; dopo, potranno dire della bellezza, della seduzione, dell’invecchiamento, dei tradimenti coniugali e dei figli che se ne vanno.
Fare storia leggendo il succedersi incessante dei fatti è affascinante e impossibile. Per esempio, quando sfogli un giornale o ascolti un notiziario, ti trovi di fronte all’accostamento incongruo di fatti che non dovrebbero avere alcuna relazione. Sono un lettore di fumetti, abituato all’affiancamento di vignette, e leggo due quadri in sequenza come se fossero un racconto, interpolando ciò che accade tra essi.
Faccio frusciare tra le dita le pagine del quotidiano di oggi e scopro fatti diversi: la strage dei manifestanti a Gaza è un argomento spinoso cui fare cenno da lontano, preferendogli l’immobilismo delle combine di un governo ancora in stallo; è morto Tom Wolfe, l’uomo che, con la sua idea di new journalism, ha messo in evidenza quanto il cronista sia coinvolto nelle storie che racconta e quanto sia visibile nelle parole che scrive (con quell’abito bianco, poi); finalmente in quel tribunale si parla del massacro del giovane Cucchi evitando, per una volta, di scomodare “malori attivi” di sorta; Spike Lee, presentando a Cannes BlacKKKlansman, il suo ultimo film, ha detto di essere “dalla parte giusta della Storia”.
In un mondo di non sequitur, in cui è vietato trovare relazioni tra eventi e notizie che a me sembrano distanti solo in apparenza, capire il presente e la storia recente è davvero un’impresa ardua. E quello è un problema etico, perché tutti vogliamo stare “dalla parte giusta della Storia”.