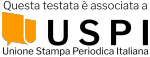Una lettura originale è quella che fa Rosalba Galvagno della figura e dell’opera di Federico De Roberto, in La litania del potere e altre illusioni (Marsilio, VE, 2017), perché svincola del tutto lo scrittore catanese dalle “categorie del positivismo, e dei suoi corollari e succedanei , naturalismo e sperimentalismo” (p. 268) in cui la critica l’aveva a volte frettolosamente collocato Pur non sottovalutando mai la “forte patina positivistica della sua produzione”, la Galvagno sostiene infatti che De Roberto può “essere annoverato tra i modelli di una nuova letteratura che indaga, nella e oltre la storia, quei moventi dell’agire umano che spesso sfuggono alla razionalità illuministica e positivistica” (p. 269). E sono soprattutto due gli strumenti che impiega a tal fine: da un lato facendo risaltare le componenti culturali che De Roberto aveva acquisito attraverso la frequentazione della coeva, e non, letteratura francese (giudicava “immenso” Flaubert la cui Madame Bovary gli servì come modello per L’illusioneErmanno Raeli aveva “mascherato” una propria traduzione de L’armonia della serapetits faits di Hippolite-Alphonse Taine), dall’altro adoperando le acquisizioni dell’analisi psicologica che le teorie psicoanalitiche ci hanno da tempo fornite (soprattutto S.Freud e J.Lacan).
L’indagine nei moventi dell’agire umano, che dopo Freud si possono definire tout court inconsci,è condotta dall’autrice attraverso un paradigma particolare: quello dell’illusione, il cui “oggetto ha una natura puramente fittizia” (p. 153): basta infatti che il velo che lo protegge si laceri e cada, affinché esso si dimostri “deludente, derisorio, […] o addirittura assente: un niente. Perché subentri la delusione,il disinganno, la frustrazione, ecc” (p. 154). Galvagno dimostra al riguardo che ciò è conforme alla stessa visione del mondo di De Roberto che, in una lettera all’amico Ferdinando Di Giorgi del 18 luglio 1891, affermava: “L’illusione […] è la stessa vita, l’esistenza…Tutta l’esistenza umana, più che i moventi dell’attività di ciascuno, si risolve in una illusione”. E richiamerà pertanto, a p. 285, persino il pensiero del grande Leopardi che, nello Zibaldone, diceva: “Tutto il reale essendo un nulla, non v’è altro di reale né altro di sostanza al mondo che illusione”.
Sotto l’aspetto strutturale, l’illusione si presenta come una triade: si ha così “il soggetto attivo o passivo dell’illusione, il velo, l’idolo. […] Se il velo è metafora di ogni sipario, se l’idolo designa i simulacri che scorrono su una scena, allora l’illusione trova il suo luogo prediletto nel teatro” (p. 287). E il “mondo come teatro sarà, com’è noto, al cuore della cultura barocca europea” (p. 294: nel volume vengono ripercorse le principali occorrenze dell’illusione, come éidolon, a partire addirittura da Omero).
Il volume della Galvagno si compone di vari saggi, la maggior parte dei quali già apparsi in rivista,
ma – a parte quello dedicato alla Guida di Catania del 1907, nella quale De Roberto avverte una “sorta di malinconica e riparatrice nostalgia” (p. 20) per la perduta grandezza della sua città – sono soprattutto tre quelli che si soffermano sulle principali opere dello scrittore (Ermanno Raeli del 1889, L’illusione del 1891 e i Viceré del 1894).
Com’è noto, i Viceré sono “la storia d’una famiglia di nobili prepotenti e stravaganti” (lettera di De Roberto a F. Di Giorgi del 3 dicembre 1891), che abbraccia circa un trentennio (1852-1882) della vita dell’Italia risorgimentale e postrisorgimentale. Ma l’Italia è per Consalvo, il discendente e protagonista, solo un “oggetto che eccita l’istinto sanguinario dei vecchi Uzeda predoni (p. 620 del romanzo, ed. Mondadori, 1984). De Roberto farà ripetere, nel celebre discorso di Consalvo c.d. della “legge” (per la candidatura al Parlamento italiano, che contrassegnerà da allora la moda del trasformismo politico), la presunta frase del deputato Gaspare d’Oragua: “Ora che l’Italia è fatta dobbiamo fare gli affari nostri” (deformazione parodica di quella di Massimo D’Azeglio “ora che l’Italia è fatta bisogna fare gli italiani”), frase che lo scrittore giudica “rivelatrice della cupidigia viceregale, della rapacità degli antichi Uzeda” (p. 864 del romanzo, ed. citata). Il contrasto fra gli ideali della dinastia borbonica e quelli rivoluzionari-garibaldini non si può comporre “se non in una precaria e illusoria conciliazione. Il discorso storico-politico è sottoposto infatti – commenta Galvagno – “alla medesima logica dualistica e inconciliabile che genera tutto il testo” (p. 29) e che ben si riassume nel termine dialettale sciarra (che ricorre in solo due luoghi). La “passione volta a soddisfare la sete di potere economico-politico e nobiliare si alimenta a sua volta di un’altra passione più originaria e fondamentale, quella dell’odio” (p. 29).
Sotto l’aspetto formale ricorre molte volte nel romanzo la figura dell’accumulazione, o“litania”, indagata da Umberto Eco (Vertigine della lista, MI, Bompiani, 2009), che spesso nella “monotonia” dei flatus vocis, sembra basarsi sulla sua funzione incantatoria, come quella dei mantra.
Ma quella che campeggia nel romanzo è, come afferma Galvagno, una “legge non codificata, più incisiva e minacciosa di quelle ordinarie” (p. 71). E’ la “legge della Madre” (archetipicamente la Pòtnia Méter), in quanto incarnata da una figura femminile, in particolare donna Teresa, la madre di Consalvo. Come ha già rilevato Leonardo Sciascia, costei è una figura di matriarcato che incombe dispotica e che, nelle sue disposizioni testamentarie, appare già delineata dalla sequenza verbale “voglio, ordino, comando, impongo”.
Se nei Viceré De Roberto ci ha dato il referto dell’illusione del potere, ne L’illusione ci ha lasciato invece quello dell’illusione amorosa. Il romanzo è un “monologo di 450 pagine” (lettera a F. Di Giorgi del 16 ottobre 1891), nel quale lo scrittore ha “saputo ascoltare le inquietudini della sua eroina isterica, come d’altronde aveva fatto Flaubert con Emma Bovary (p. 143: Lionello Sozzi, ne Il paese delle chimere, Sellerio, PA, 2007, sostiene che il romanzo dipenda “largamente” da Madame Bovary). Questo monologo si configura sintatticamente come un dialogo (una domanda rivolta a un “tu”, l’Altro o Teresa stessa) che viene definito come “discorso del transfert” (legame affettivo del paziente con l’analista, automatico, ineludibile e indipendente da ogni contenuto di realtà). Alla base del quale c’è “un’insaziabile domanda d’amore”, destinata a rimanere insoddisfatta, perché la dipendenza dall’Altro si risolve in una costante “oscillazione tra momenti di esaltazione euforica e momenti di caduta disforica” (p. 184). Se, “a differenza di Italo Svevo, De Roberto non ebbe modo di frequentare la psicoanalisi, tuttavia può essere annoverato […] tra quei poeti che hanno presagito le stesse verità che scopre l’analista, […] riuscendo ad articolare […] stilisticamente quel discorso del transfert che Freud scoprirà all’incirca negli stessi anni ma che comincerà a teorizzare a partire dal 1908” (p. 209).
Nell’Avvertimento alla seconda edizione integrata, del 1923, del suo primo romanzo Ermanno Raeli, De Roberto ne giustifica la ristampa non per i suoi valori formali, ma per il suo valore di testimonianza storica esemplare (far conoscere alle più giovani generazioni il “come eravamo” della generazione del 1889). Il romanzo resta infatti “ancorato alla poetica del documento umano” (p. 243: tratta un caso di suicidio, di cui si possono riscontrare gli equivalenti in Malombra di Fogazzaro del 1881, in Una vita di Svevo del 1892 e nel Trionfo della morte di D’Annunzio del 1894). Il protagonista è un giovane di 28 anni, che vive a Palermo intorno al 1885, e che “avuta la ventura di innamorarsi della giovane Massimiliana di Charmory la perde nel momento stesso in cui tenta finalmente di possederla” (p. 246). Si suiciderà subito dopo un nuovo incontro del 1889.
Il romanzo, afferma Galvagno, non è che una sequela di illusioni. A cominciare da quella filosofica, i cui studi hanno solo prodotto una crisi di scetticismo (in un saggio, mascherato, dello scrittore si afferma: “L’unico oggetto che noi abbiamo a nostra portata, siamo noi stessi: il mondo non è altro che un miraggio della nostra coscienza”). Segue quella del viaggio, perché, durante un giro in Europa, a Vienna Stefania Woiwoski l’aveva tradito per un altro amante. L’illusione teatrale era avvenuta a Parigi, dove il protagonista aveva assistito alla rappresentazione della Signora delle camelie di A.Dumas, ma dove, comprato il romanzo, non ne aveva proseguito la lettura per il timore di profanare la figura di Margherita. Infine c’era stata l’illusione artistica, con la quale aveva avuto un’infatuazione per Pietro Novelli detto il Monrealese, e proprio quando aveva fatto da cicerone al Museo per far vedere una sua pittura a Massimiliana di Charmory, si era innamorato di lei. Ermanno dunque è un “amante mancato perché incapace d’amare e si suicida in séguito a uno scacco amoroso particolarmente traumatico. […] Il malessere di cui soffre è […] denominato dalla psicologia del tempo malattia della volontà, che a fine secolo eredita e soppianta la grande malattia romantica (il wertheriano taedium vitae) o maladie du siècle, quella particolare malattia dell’anima che la psicoanalisi definirà nevrosi” (p. 263).
L’approfondita analisi di Galvagno non poteva non concludersi con un’altra illusione, quella terapeutica, che ci svela come De Roberto – fra tutti gli scrittori a cavallo fra Otto e Novecento – sia il solo (a parte l’esperienza di Italo Svevo) ad aver tentato una vera e propria “terapia dell’anima” . Nell’articolo La medicina dello spirito, apparso sul “Giornale d’Italia” del 3 aprile 1911, volle infatti esprimere gratitudine al Dr. Dubois, il medico di Berna che gli regalò “l’effimera requie di un’illusoria guarigione” (p. 267: la sua sofferenza nevrotica , convertitasi in nevrosi gastrica l’aveva persino indotto, durante uno dei suoi soggiorni a Zafferana Etnea, a mangiare “un chilo di ricotta, in tre volte” in una giornata, come scrisse alla madre).
ROSALBA GALVAGNO, La litania del potere e altre illusioni, Marsilio, VE, 2017, € 28,00.