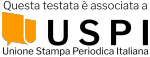Mi dico che sarà facile. Lo faccio per tenermi tranquillo e lo so che non sarà facile – ah, se lo so! – ma mi piace essere clemente con me stesso. Mi dico che per fare una rubrica che riesca ad avere le caratteristiche che ci si aspetta da una rubrica – interesse, costanza e coerenza – basta avere un’idea semplice e facilmente comunicabile. E, allora, ingenuo come sono, mi dico che non c’è nulla di più semplice di due parole che sembrano il “pay-off” di un pubblicitario in affanno. Ci aggiungo perfino un cancelletto davanti, trasformando il tutto in un contemporaneissimo hashtag, e sono contento di poter arpeggiare finalmente sulla tastiera. Pigio contemporaneamente i tasti CONTROL, ALT e “à” e mi sento un po’ Glenn Gould.
Poi mi fermo e penso alle mie due parole. Avrò scelto quelle giuste?
Prendi “quasi”. L’avverbio che più di tutti toglie vigore. Attenua, approssima, indica uno stato di inferiorità rispetto alle parole che seguono. E si riferisce tanto alle quantità quanto alle qualità. Ma davvero voglio parlare di cose meno importanti delle parola che segue?
Ah… già! Bella forza quella parola lì, "fumetto"… Ancora non ha deciso se è la nuvoletta, il racconto che la contiene, un liquore d’anice o un brodetto di pesce.
Facciamola facile: con “fumetto” mi riferisco al racconto con le figure. La definizione la sai, no? Come dici? È imprecisa? E sì… e poi? Mi dirai anche che il re è nudo e gli si vedono le chiappe e il risibile pisellino?
Dici che se non fosse imprecisa non servirebbero tutte quelle parole diverse che a volte falliscono il tentativo di precisare e altre quello di nobilitare?
#porcamiseria!
Innanzi tutto, la definizione di “fumetto” è resa complicata dall’assenza di un formato di pubblicazione unico. Nel corso della sua storia moderna, abbiamo visto quell’oggetto culturale non identificato (la definizione è di Thierry Groensteen) assumere forma di striscia di poche vignette o di gigantesca pagina di quotidiano, di storia breve o lunghissima, di racconto a puntate o da consumarsi in un’unica soluzione, di albo spesso o sottile o di libro prezioso a volte chiamato addirittura “graphic novel”, di oggetto di carta o di mappa di bit da accarezzare sullo schermo del cellulare o del tablet…
Al suo interno ci possono essere racconti seriali o storie autoconclusive, storie di umanissimi dolori e guerre stellari, il giallo, il rosa, il nero, e tutti gli altri colori dei generi più semplici ma anche diari e narrazioni che rifuggono qualsiasi classificazione.
E poi il balloon – il fumetto, appunto – ci deve essere o no? Parrebbe non servire, infatti a volte non c’è ed è fumetto lo stesso. E allora la sequenza? Ah! Quella, sì.. è proprio necessaria! Ma mica ce le ha solo il fumetto le sequenze e le giustapposizioni di immagini.
È serialità? Paraletteratura? L’unica forma di racconto in grado di raccontare la contemporaneità? Arte sequenziale? Letteratura disegnata? E che altro, poi?
#porcamiseria!
La natura della bestia
Il fumetto è quella cosa che definiamo male e con grande approssimazione, costruendo volumi di centinaia (a volte migliaia) di pagine che hanno il solo scopo di rendere ancora più vago l’oggetto di analisi. Ogni volta che aggiungiamo parole per indicare meglio quella cosa, l’ambiguità semantica ci schiaccia e ci sommerge.
Eppure, anche se non siamo in grado di definirlo, lo riconosciamo con grande facilità. Se ne vediamo uno, mica veniamo colti da tutte queste paturnie: lo afferriamo e lo leggiamo, contenti di affondare il naso e i pensieri in un fumetto.
Se mi hai seguito fino a qui, scusami. Ti ho importunato: questo discorso è un’oziosa scocciatura! Per riprendermi, mi fermo un attimo e sfoglio un libro. Uno di quelli seri, che mica hanno bisogno di qualcuno che racconti che quella è cultura. È un saggio – bellissimo! – di storia dell’arte. Lo ha scritto il lituano Jurgis Baltraušaitis che lo ha pubblicato per la prima volte, in francese, nel 1955. Si intitola Il Medioevo fantastico: Antichità ed esoterismo nell’arte gotica. Mentre lo tengo in mano, nella sua bella edizione in brossura continuamente ristampata dal 1973 da Adelphi, il peso di quel volume mi tranquillizza. Mi avventuro tra mostri e creature, grilli gastrocefali e danze di morte, divinità acefale e pipistrelli, diavoli cinesi e arabeschi, … E, improvvisamente, oscillando tra i bestiari e i disegni miniati sul bordo dei manoscritti, tra le meraviglie artistiche e narrative cinesi e l’arte sintetica e totalizzante del fiammingo Hieronymus Bosch, tutto diventa più chiaro.
Quel “quasi”, addirittura non mi spaventa più.
L’Albero della Vita
Prima di essere il lascito un po’ pacchiano che un’Esposizione Universale ha fatto alla città di Milano, l’Albero della Vita è stato uno degli innumerevoli modi con i quali il Medioevo ha tentato di ricordarci la nostra caducità.
Sfogliando Il Medioevo fantastico si rileva quanto il “memento mori” sia stato uno dei temi artistici più ricorrenti di quell’arco temporale. Quindi il grido che il monaco trappista indirizzava alla volta di Massimo Troisi, nel film Non ci resta che piangere, non era un’esagerazione. «Ricordati che devi morire!» «Sì, sì… no… mo' me lo segno.», rispondeva il comico napoletano.
Baltraušaitis mi spiega: «Le piante dai frutti zoomorfici derivano da una duplice tradizione: ornamentale e leggendaria. All’origina c’è l’Albero della Vita, di una vita così impetuosa e così selvaggia che fa esplodere la cornice vegetale.»
Poi, il lituano mi racconta una favole bellissima: «Il re dei Ta-Shih [gli Arabi] aveva inviato degli uomini che, saliti su un battello e presi con sé vestiti e viveri, si misero in mare. Dopo otto anni videro uno scoglio quadrato. Su questo scoglio vi era un albero i cui fiori erano rossi e le foglie verdi. Sull’albero era sbocciata una folla di bambini; erano lunghi da sei a sette pollici; quando vedevano gli uomini non parlavano, ma tutti potevano ridere e agitarsi. Mani, piedi e teste aderivano ai rami dell’albero. Quando gli uomini li staccavano e li coglievano, non appena erano fra le loro mani, i bambini si seccavano e diventavano neri. Gli inviati ritornarono con un ramo di quest’albero che ora di trova nella residenza dei Ta-Shih.»
Questo racconto, che risale alla seconda metà dell’Ottavo secolo, presenta il primo nucleo narrativo che ha al suo centro una pianta il cui nome che preferisco è albero «wakwak».
Come è fatto? Guardiamolo insieme. Si tratta di un Albero della Vita – ma anche della Morte – che ha funzione decorativa e pedagogica. I frutti sono grandi come zucche e hanno forma di cranio umano. Sono disposti in semicerchio. Quelli più a sinistra hanno fattezze di volto di bimbo. Poi, spostando lo sguardo in senso orario, l’osservatore vede qui volti invecchiare. Che spavento quando si capisce che i frutti più a destra hanno forma di teschi. Si staccano e, non appena toccano il suolo, vanno in frantumi con un verso orribile: «Wakwak!»
«Ricordati che devi morire!» Certo. Però l’artista non si fida tanto delle mie capacità mnemoniche e, per aiutarmi, mi racconta delle storie, usando delle sequenze narrative. E, in quel racconto, io mi ci perdo.
Guardalo anche tu. Questo è l’Albero della Vita e della Morte che decora la tomba di Enrico di Festingen, morto nel 1286, a Trier.
Quasi quasi tolgo il quasi.