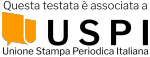Provincia addormentata o sognante. Specchio invisibile o volti vissuti oltre l’oblio. Michele Prisco resta uno scrittore riferimento. A cento anni dalla nascita. Anzi, un vero scrittore che ha sempre legato il travolgere, o l’avvolgere, dei personaggi non alle forme, o agli ambienti, bensì ai destini.
In un sommerso orizzonte, in cui la lingua ha la sua importanza in una eleganza
fuori gli stereotipi, il raccontare è da leggersi come un narrare dove la
letteratura è la vita stessa.
Aveva perfettamente ragione Carlo Bo.
In Prisco il dettaglio ha la sua percezione e quindi la sua perfezione. Sia nel
romanzo che in quel suo fare giornalismo, dettato da un appiglio di cronaca ma
definito in un preciso affresco di vita, appunto, e di letteratura, il
raccontare era tutto.
I suoi romanzi, a volte in una elegante solitudine, non sono la descrizione, o
una descrizione, ma una impeccabile metafora, dove il reale si trasforma in un
invisibile sguardo nel tempo che sa di nascere dalla memoria e dal ricordo. Il
reale non cerca il vero. Perché la letteratura non è reale e tanto meno vero.
Mistero certamente sì. Il mistero ha sempre di fronte l’altro aspetto del
destino. Ovvero l’invisibile, che, però, attraversa gli occhi che non restano
addormentati ma sognanti.
Prisco non ha maestri considerati
tali se non la tradizione di un intreccio che ha sede nel narrare l’eredità
della conoscenza del sentire lo sguardo come visione, a volte, ontologica a
volte allegorica, in una pacata religiosità della parola, che diventa immagine.
Un immaginario che non è “collettivo”, perché non esiste e perché è
una frase abusata ideologicamente, ma individuale personale umano.
Già, perché Prisco pone al centro non le cose, o meglio mai le cose bensì la persona. I suoi romanzi, ma anche i suoi ritratti, sono la dimensione dell’umano. L’uomo come linguaggio dell’essere e mai delle circostanze o del relativo. Il relativo non esiste se esiste l’uomo con la sua identità. È questo che lo caratterizza e lo rende maestro e unico. È questo che lo distingue da Calvino, da Moravia e da Pasolini. Prisco è il vero scrittore che nasce proprio dal legame parola vita e non da strutture culturali o sovrastruttura. È lo scrittore che nasce e vive abitando la sua anima e i suoi sensi sia nella lingua sia nella costruzione invenzione del suo immaginario di tempo.
Infatti dirà: “…il ruolo dello scrittore
non è quello di suggerire delle soluzioni perché la sua missione è ad un tempo
più modesta e più alta: il romanziere deve forzare il lettore ad interrogare su
se stesso e sul senso del suo destino“. Il senso del destino che
ristabilisce le stanze delle vite all’interno di un tempo che non è mai
cronaca. Il senso della letteratura nel destino dell’uomo che si fa personaggio
e persona. Così da “La provincia
addormentata” a “Una
spirale di nebbia“, da “Le
parole del silenzio” a “I
cieli della sera“.
Proprio in “Una spirale di nebbia”
scriverà questa sublime visione: “E
così continuava a fissare assorta la fotografia di sua madre e a
rincorrere l’immagine di Valeria, ormai persa abbandonata dietro questo giuoco
di sovrimpressioni: e forse perché adesso doveva pensarla morta, eliminata per
sempre, avvertiva a un tratto un vago turbamento, un rimorso, no, non proprio
un rimorso, semmai un’insofferenza confusa e delusa, una specie di, come
poteva definirla, di necessità di riparazione, ma neppure è l’espressione
giusta, di maggiore tolleranza e umanità, di ordine, ecco, di pulizia. Per
quel bisogno che abbiamo, di fronte alla morte, di sistemare
per bene i nostri rapporti con coloro che ci hanno preceduti evitando
di lasciare zone d’ombra, sentimenti di cruccio o d’acredine, quasi per
sentirsi in pace con noi stessi più che per non sentirsi in debito con loro.
Quasi per farci perdonare d’essere ancora vivi…”. Un segno
metaforicamente pirandelliano che ci regala il dialogo di Luigi con la
madre. Lo scrittore forza si riconosce subito. Prisco.
E ancora da “I giorni della conchiglia” a “Il cuore della vita“, da “Il pellicano di pietra” a “La pietra bianca. Quattro racconti inediti“. Poi i suoi incontri con Manzoni, con Cechov, con Matilde Serao, con Gianbattista Basile, con il cinema. I suoi legami con Mario Pomilio, Francesco Grisi, Diego Fabbri. Quella provincia addormentata è un Mediterraneo diffuso tra luoghi e uomini, tra personaggi e specchi, tra la trasparenza delle maschere e il ricordare nella immensa memoria che va oltre Napoli e la Campania.
Lo scrittore di un vissuto. Era nato a Torre Annunziata il 4 gennaio del 1920. Morto a Napoli il 19 novembre del 2003. Aveva l’età di mio padre, 1920, ed è stato dichiarato all’ufficio anagrafe il 18 gennaio. Il giorno della mia nascita. Ebbi modo a metà degli anni ’90 (1995 – 2000) di avere rapporti con Michele, di frequentarlo spesso, di ascoltarlo con frequenza. Lo chiamai per il Premio Ori di Taranto e il Premio Bari Mediterraneo a far parte della commissione. Allora ero vice presidente e assessore alla cultura alla Provincia di Taranto.
Il tempo è passato. Ma il passato resta. Lo scrittore di una ricchezza
raffinata, di una eleganza superiore, di una profondità archetipica. Gli
archetipi che diventano poesia, così: “…ogni parola ha sempre le sue origini nella sostanza umana e il canto si
realizza come passione, sofferenza, denuncia, realtà interiore e anelito di
liberazione, recupero di smarriti modi di vita… ‘Caro, dolce poeta’ è un
messaggio destinato a ciascuno di noi, una voce che ciascuno di noi può sentire
echeggiare dentro di sé. Obbedirle, o solamente accoglierla, è già altro
discorso: al poeta basta farla vibrare“.