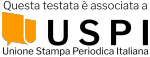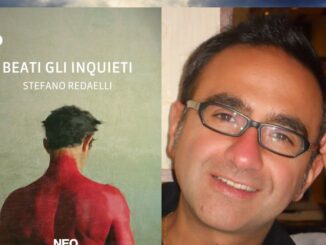In La terrazza della Noce (Navarra Ed., PA, 2020) l’agrigentino Gaspare Agnello riversa i suoi “ricordi di vita con Leonardo Sciascia”, essendo stato, da un lato suo “collega” perché insegnante elementare nello stesso distretto (anche se più giovane di tredici anni), dall’altro perché, in qualità di presidente del Premio Racalmare istituito nel 1980 dalla città di Grotte (confinante con Racalmuto), aveva modo di frequentare quella terrazza di contrada Noce dove Sciascia si rifugiava d’estate per scrivere i suoi libri e di incontrare quindi, oltre al “maestro”, anche “tanti intellettuali italiani e stranieri che mi hanno arricchito e […] mi hanno consentito di vivere una seconda esistenza con i libri” (p. 26). Giustamente nella prefazione Matteo Collura – che fu il primo vincitore del Premio nell’aprile 1982 con il libro Associazione indigenti, pubblicato da Einaudi – sottolinea che il maggior pregio del libro sono “la passione, l’affetto, la sincerità” con cui è stato scritto, come testimonia questo passaggio che l’autore pone in premessa: “Raccontare quali sono stati i miei rapporti con uno dei maggiori scrittori del Novecento italiano potrebbe essere ritenuto millantato credito […] e questo mi ha bloccato per tanti anni [la gestazione è durata trent’anni]. Poi mi sono confrontato con alcuni critici letterari […] e qualcuno mi ha persino detto che avevo il dovere di scrivere di quel rapporto intenso […], con la necessaria avvertenza che Sciascia era il grande letterato che tutti conosciamo, mentre io ero un principiante […] per cui prendevo grosse cantonate che lui mi perdonava con il suo sorriso bonario […]” (p. 10).
E l’affettuosa sincerità dell’autore è via via testimoniata da tutte le volte in cui, insieme con tanti componenti della giuria, ammette che “noi non eravamo culturalmente attrezzati” (p. 66) e perciò le divergenze con le indicazioni di Sciascia diventano manifeste nell’assegnazione delle varie edizioni del Premio: a prescindere infatti dalla prima con il libro di Collura, sono molte quelle successive che non siano “travagliate”.

Alla seconda, infatti, nel 1986 (avvenne uno slittamento temporale), il Premio fu assegnato a L’uomo invaso di Gesualdo Bufalino, dopo che erano tramontate le indicazioni sciasciane per I testimoni di Cesare Greppi e per Passi a piedi passi a memoria di Antonio Castelli, che successivamente si tolse la vita (per questo, quando Maria Andronico, la moglie di Sciascia, divenne presidente nel 1988, il Premio gli fu assegnato in memoriam). Alla terza edizione, nel 1987, fu premiato La ragazza col turbante di Marta Morazzoni, dopo che erano state scartate sia l’indicazione di Sciascia per Breve storia della Sicilia di Christopher Duggan (un allievo di Mack Smith) sia quella dello stesso Agnello per Il sergente della neve di Mario Rigoni Stern (ma nel merito del libro della Morazzoni Agnello confesserà di essere sempre del parere dell’insegnate Alaimo – alla quale lo aveva dato da leggere – perché “vi difettano i motivi sentimentali””, p. 71). Tutto fu più semplice per la quarta, nel 1988, quando il Premio fu assegnato a Retablo di Vincenzo Consolo: e fu questa l’ultima volta a cui partecipò Sciascia. Per la quinta del 1989, Sciascia – anche se da lontano – insistette per premiare Assassinio al Comitato Centrale di Manuel Vàsquez Montalbàn, che poi andò a trovarlo a casa pochi giorni prima della sua scomparsa.
Le memorie di Agnello sono scandite da capitoletti, quasi per argumentum, forse perché ciò aiutava a ricordare fatti avvenuti a tanta distanza di tempo (e sulla memoria, e sulle sue lacune, sono riportati alcuni brani, oltre i passaggi dello stesso autore). Uno di questi capitoletti riguarda un certo Gonzalo Ἁlvarez Garcìa, che era il rettore della chiesa spagnola di S.Maria de Soledad, nei pressi del Palazzo dei Normanni di Palermo. Costui aveva scritto un libello su Sciascia (Le zie di Leonardo, Scheiwiller, MI, 1985), dopo che dallo scrittore era stato aiutato in tanti modi (anche finanziariamente). Lo spagnolo si era spretato e aveva sposato una siciliana, ma Agnello ritiene gusto che egli abbia sollevato il “problema della religiosità e del rapporto con le donne”(p. 56) nelle opere di Sciascia. Sulla religiosità diremo appresso. Ma per quanto riguarda i personaggi femminili, anche se è vero che l’unica scena erotica nei suoi romanzi è quella del Candido quando un’infermiera, per uno scossone del treno, va a finire addosso al protagonista, va precisato che gli argomenti dell’arte di Sciascia non erano quelli della c.d. “letteratura rosa”. Come afferma Massimo Onofri, che fra i critici è ritenuto uno dei suoi più importanti, il suo obiettivo era “la storia come luogo della menzogna e della violenza” e “ci pare si possa dire che egli, con Giuseppe Antonio Borgese, Vitaliano Brancati, Pier Paolo Pasolini, sia stato tra i rari scrittori di questo secolo che […] affidarono alle loro pagine un senso, se non il senso, di una storia d’Italia” (Nel nome dei padri, Ed. La Vita Felice, Mi, 1998, p. 12 e p. 16). Per questo ci sembra improprio che l’autore abbia anche citato le confessioni della figlia più piccola di Sciascia, Anna Maria, che riferendosi alla moglie e alla figlia di Pirandello (Antonietta Portulano e Lietta), vede delle “affinità e delle corrispondenze fra loro e me, prevalentemente fra tutte il senso di solitudine e di emarginazione: sperdute nella vita, inadeguate sempre e ovunque” (Il gioco dei padri: Pirandello e Sciascia, 2009). Quello di Anna Maria è stato solo uno sfogo introspettivo, quello che con metafora psicoanalitica freudiana si chiama “uccisione del padre” e che magistralmente lo stesso Sciascia così descrive: “quel rapporto col padre: che si riscontra dapprima sentendolo come ingiusta e ossessiva autorità e repressione poi sollevandoci alla ribellione e al rifiuto; e infine liberamente e tranquillamente vagliandolo e accettandolo, più nel riscontro delle somiglianze che in quello, tipicamente adolescenziale, delle diversità” (Pirandello mio padre, in “Micromega”, 1989, 1, p. 34).
D’altra parte è anche vero che la donna, nella narrativa di Sciascia, è quella ancestrale che imperava un tempo in Sicilia (ormai scomparsa con la rivoluzione culturale subentrata nei costumi e nella cultura diffusa, a partire almeno dal “caso” Viola, quando per la prima volta una ragazza isolana che era stata stuprata rifiutò il c.d. “matrimonio riparatore”, poi abolito nel codice penale). Egli stesso parlò della “mostruosità del vecchio matriarcato in Sicilia, e del […] loro ricorso a uno spaventoso conformismo sociale” (La Sicilia come metafora, Mondadori, MI, 1979, pp. 13/14). Nello stesso libro (p. 37), fa addirittura risalire, “con una punta di malizia, a quando ho fatto perdere a Candido la madre al momento dello sbarco americano in Sicilia, che quindi coincide con l’inizio delle fine del terribile matriarcato siculo”. Questa donna matriarca, peraltro, era quella che vedeva nella società siciliana della sua infanzia e adolescenza, quella da cui si liberò con la ragione della maturità, al pari di tutto il “pirandellismo” di allora: “I personaggi pirandelliani sono lucidi notomizzatori, dei propri sentimenti e dei propri guai, presi fino al delirio della passione e del ‘ragionare’ ancor più che da quella per le donne e per la roba” (Pirandello dall’A alla Z, L’Espresso, RM, 1986, p. 28). Commenta al riguardo Massimo Onofri: “Si potrebbe qui fornire esemplificazione di ciò che Sciascia chiama sicilitudine a partire da quel sentimento della roba che prende vita nelle opere di Verga, arrivando, attraverso molte tappe, a quel vagheggiamento della donna o ‘stilnovismo patologico’ che segna i libri di Brancati, per spingersi fino a quella ‘compiaciuta attesa del nulla’ che, secondo Tomasi di Lampedusa, cagiona la peculiare follia siciliana” (Nel nome dei padri, citato, p. 31). Per concludere infine: “Nei libri pirandelliani […] si rinquadernava quel mondo dell’infanzia e dell’adolescenza in cui Sciascia aveva vissuto, acquistando nuova evidenza. […] Da questa Sicilia Sciascia mosse, faticosamente e in solitudine, cercando i mezzi per reagire, approdando, come scrive più volte, a quella difficilissima fede nella ragione umana, e nella libertà e nella giustizia che da quella ragione scaturiscono […]. Sciascia perseguì un’interpretazione della opera pirandelliana che convertisse l’irrazionale realtà ivi rispecchiata in razionale conoscenza” (Ivi, p. 21/22).
Ci sarebbe qualche altra osservazione da fare sul libro di Agnello, anche sotto l’aspetto tecnico (a esempio si poteva evitare qualche ripetizione in più), ma preferiamo soffermarci sulla questione della religiosità di Sciascia. Proprio Ἁlvarez Garcìa, nel suo libello sopra richiamato, affermava che egli “confonde religiosità con cattolicesimo”. Niente di più falso: la sua religiosità oltrepassava gli stretti binari della dialettica cattolicesimo/cristianesimo (quest’ultimo, come si sa, ha molte confessioni e persino numerose sette). Anche se Sciascia aveva scritto la prefazione a un libro fotografico sulle Feste religiose in Sicilia, ovviamente cattoliche, dove aveva “notato la refrattarietà quasi assoluta dei siciliani alla religione”, aveva poi precisato: “Non senza rammarico: perché se i popoli religiosi sono capaci di fare rivoluzioni religiose, sanno però anche dare il via a rivoluzioni civili” (La Sicilia come metafora, citato, p. 64).

Quando Agnello, la mattina del 20 novembre 1989 entrò tra i primi, con Ferdinando Scianna, nella casa di Sciascia, fu poi turbato dal veder comporre la salma nella bara con un crocefisso tra le mani (il feretro fu poi fatto passare da Grotte prima che la cerimonia funebre venisse celebrata nella Chiesa del Monte di Racalmuto dal vescovo Ferraro di Agrigento, cui Sciascia tempo prima aveva donato un calice d’oro). Agnello commenta: “No so se Sciascia avrebbe approvato che da morto gli mettessero un crocefisso tra le mani, ma sono certo che avrebbe voluto il funerale celebrato nella sua Chiesa del Monte, come tutti i racalmutesi. Sciascia non morì da cattolico, ma sicuramente da cristiano. Aveva detto infatti: ‘Non sono né ateo né credente, ma cerco di vivere religiosamente’” (p. 106). E riporta subito dopo una citazione pascaliana. A noi pare invece che, più di Pascal, la connotazione religiosa di Sciascia sia quella di un Dio impersonale, come il Deus sive Natura di Spinoza, in conformità peraltro a quanto aveva già detto: “La religione va vissuta giorno per giorno, in conflitto con noi stessi, e anche dolorosamente; non è passiva accettazione di una verità una volta per tutte rivelatasi e in cui credere soltanto attraverso atti di routine. Non occorre nemmeno essere certi dell’esistenza di Dio per essere religiosi o credere nell’immortalità dell’anima: basta soltanto essere certi che la nostra esistenza, questo nostro mondo, deve avere un qualche senso, un qualche significato” (Ivi, p. 64).
GASPARE AGNELLO, La terrazza della Noce, Navarra Editore, PA, 2020, € 10,00.